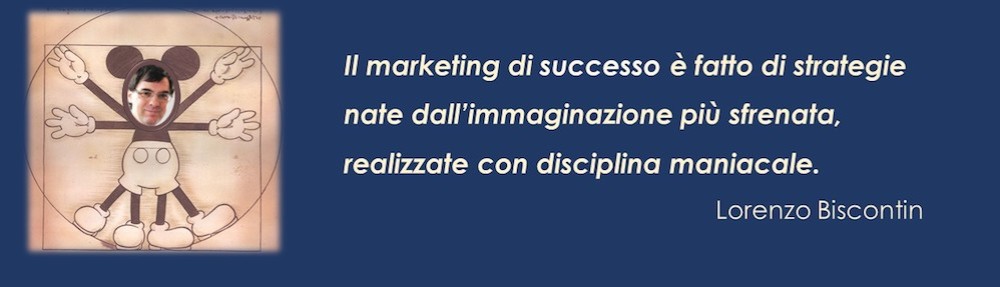Oggi torno all’essenza più pura del bisco-marketing, ossia del marketing secondo me (boom!) e lo faccio trattando un argomento apparentemente teorico, ma in realtà molto pratico, che spesso non viene approfondito come merita nella disciplina di marketing (premetto che ahimè ho lasciato in ufficio il Libro, intendo Marketing Management del Kotler, e quindi non sono riuscito a verificarne la trattazione che ne fa la bibbia del marketing.)
Se divento dottrinale fermatemi.
La migliore definizione di posizionamento rimane quella che ho sentito Thomas Funk, mio prof. di marketing in Canada, in una gelida mattina di dicembre (inizio lezione ore 8:00 a.m.): “il vostro posizionamento è quello che rappresentate nella testa del consumatore” (definizione che credo comunque essere Kotleriana).
Con l’esperienza di questi anni di lavoro io modificherei leggermente questa definizione e direi che “il posizionamento definisce quello una marca/organizzazione vuole rappresentare per il mercato”, dove “mercato” va inteso nell’accezione più ampia dei portatori di interessi (stakeholders). Poi ogni marca deciderà con quanta forza e con quali aspetti della propria personalità vuole rappresentare qualcosa per i diversi segmenti di portatori di interessi (lo so: ho già inserito altri concetti senza spiegarli, continuate a leggere …).
In realtà sono vere entrambe le definizioni, come spiega con estrema chiarezza questo post del Dr. Narayana Rao che raccoglie il pensiero di Kotler.
La seconda definizione si riferisce alla definizione dell’identità della marca, mentre la prima all’immagine che ne viene percepita dai consumatori.
E’ evidente che quanto la definizione dell’identità è chiara, forte e coerente con l’effettiva personalità della marca e tanto più ci sarà corrispondenza tra questa e l’immagine proiettata, quindi percepita, all’esterno.
Il “vuole” nella mia definizione infatti non significa che la definizione del posizionamento che rappresenta la personalità aziendale deve essere un auspicio. Significa che la definizoine del posizionamento deve esprimere una tensione verso quelli che SONO i valori dell’azienda e,soprattutto, verso la loro realizzazione con tutte le attività aziendali. “Vuole” sottolinea il fatto che la definizoine del posizionamento rappresenta una scelta che va confermata continuamente con il proprio comportamento.
Ne consegue che la definizione del posizionamento non può essere la somma delle diverse percezioni di sè e del proprio ruolo (come marca/organizzazione) che hanno le diverse persone/funzioni, ma deve esserne la SINTESI.
Solo in questo modo riuscirà ad essere allo stesso tempo precisa nel rappresentare la marca/organizzazione in modo chiaro ed unico, ma sufficientemente ampia da rappresentare un punto di convergenza per tutte le persone coinvolte con la marca/organizzazione.
Solo in questo modo diventerà la “mano invisibile” (termine utilizzato da kotler riferendosi alla mission aziendale) che allinea “automaticamente” tutte le attività legate alla marca/organizzazione (sia che vengano realizzate da soggeti interni che esterni all’organizzazione) verso un unico sistema di valori coerente perchè condiviso.
Questo si traduce in maggiore efficenza ed efficacia nell’attività dell’organizzazione perchè il posizionamento scelto definisce quali ambiti gli appartengono e quali no e come i primi vanno presidiati. In parole povere cosa e come l’organizzazione può e deve fare (prima che mi diventiate troppo talebani vi linko un mio vecchio post dal titolo: “Il posizionamento della vostra marca è davvero così stretto?”).
Viceversa se la definizione del posizionamento risulta generica, espressione di auspipci più che di aspirazioni legittimate dalla realtà aziendale, o, peggio ancora, avulsa dall’affettiva personalità dell’organizzazione si trasforma in un formalismo inutile o, più spesso, dannoso.
Crea infatti delle inefficienze per l’incoerenza tra quello che si dichiara di voler fare e quello che si può e vuole effettivamente fare.
Mi rendo conto che forse sarebbe opportuno spipegare un po’ più diffusamente qualche concetto, però e già tardi quindi vi auguro buonanotte e resto disponibile a tutti gli spunti che vorrete darmi con i commenti.