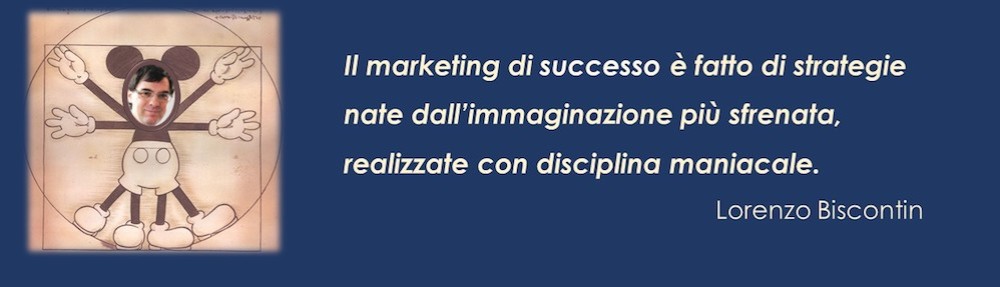“A man who has committed a mistake and doesn’t correct it, is committing another mistake.”
- Confucius
Author Archives: Lorenzo
illy, Lavazza ed il riciclo delle capsule
Leggo sul numero di aprile della rivista della COOP nella rubrica “Italiani brava gente” a firma Cirri-Solibello (conduttori di “Caterpillar” su radio2, mio appuntamento fisso se sono in macchina dalle 18:00 alle 19:30) l’esperienza di riciclo del comune di Capannori, provincia di Lucca.
A Capannori hanno un progetto chiamato “Rifiuti Zero” per arrivare entro il 2020 e non produrre più alcun rifiuto. Oggi sono all’81% di differenziata ed hanno attivato diverse azioni per evitare la produzione di rifiuti a monte (prima del riciclo c’è il minor uso come insegna la famosa regola delle 3 R dell’ecosostenibilità: nell’ordine RIDUCI, RIUSA, RICICLA). Secondo questo approccio sono andati ad analizzare cosa c’è in quel 19% di rifiuti non differenziabili ed hanno scoperto che un volume rilevante è dovuto alle capsule per l’espresso fatto con le macchinette da uso domestico/ufficio. A Capannori ogni anno ne utilizzano 750.000 del 1.000.000.000 che se ne consumano in Italia.
Queste capsule sono indifferenziabili perchè non possono essere riciclate con la plastica a causa della polvere di caffè che contengono e, meno che meno, possono essere riciclate come materiale organico a causa della plastica di cui sono fatte.
Allora l’assessore all’Ambiente di Capannori ha scritto alla Lavazza per stimolare lo sviluppo industriale delle alternative già esistenti, tipo capsule biodegradabili, riciclabili o cialde in carta compostabili. Para che la Lavazza abbia colto lo spunto e ci stiano lavorando.
Fin qui la cronaca, ma perchè ne sto parlando? Perchè di questo articolo mi hanno colpito alcune cose.
La prima è che poco meno di un anno fa affrontavo su questo blog la medesima questione, analizzando la posizione di Illy. Scoprire di essere in sintonia (e magari un po’ in anticipo) con quello che succede nel mondo è sempre una bella rissicurazione.
Soprattutto però mi ha colpito il fatto che i signori di Capannori si siano rivolti a Lavazza, quando proprio illy è stato tra i pionieri nell’ideazione delle cialde.
Lavazza è storicamente l’azienda leader in Italia nel mercato del caffè in termini di quota di mercato, ma illy aveva una leadership che io ritengo più importante: la leadership delle idee.
In altri termini illy era chiaramente il leder italiano (e non solo) del caffè nella definizione dello scenario, di contorni, del settore. Era il riferimento per tutti, consumatori, intermediari commerciali e concorrenti. Scrivo era perchè il fatto che i signori di Capannori si siano rivolti a Lavazza mi sembra un (ulteriore) segnale della perdita di questa leadership.
Ed è un peccato perchè, anche riguardo all’espresso in casa, le idee le aveva tutte in anticipo, con l’ideazione del sistema E.S.E. che prevedeva l’utilizzo di cialde (compostabili) e, soprattutto, l’utilizzo gratuito del brevetto disponibile per tutti. Si evitavano così le inefficenze intrinseche al monopolio di fatto con cui lavorano attualmente le principali case di caffè (illy compresa).
Perchè è successo? Questo ovviamente non lo so. Qualcuno potrebbe dire che è il naturale ciclo di vita delle marche, ma è una visione che io contesto perchè le marche non sono organismi soggetti ai cicli biologici (le persone che le gestiscono però sì), ma sono entità che si alimentano con le idee. D’altra parte anche Lavazza è una marca con di età ragguardevole.
Quello che mi viene da ipotizzare è che illy abbia provato a fare Lavazza, dimenticandosi che se ci si era avvicinata in termini di dimensione era proprio grazie al fatto che proponeva al pubblico uno stile diverso. Stile che ad un certo punto non ha più avuto il coraggio di seguire fino in fondo.
Lavazza invece ha imparato a fare illy (penso al collegamento con l’arte, il design o l’alta cucina), portandosi quantomeno allo stesso livello, sia in termini di qualità intrinseca (capsule+macchine per espresso) che di interlocutore pubblico sulle questioni legate al caffè.
Rivedendo nel mio post dell’anno scorso le dichiarazioni di Andrea Illy sulla riciclabilità delle capsule, spero per l’azienda che fossero frutto dell’amor proprio e non di disonestà intellettuale.
Gestione del personale ed etologia 4
Asterix: Non dovrebbe essere troppo lontano, e a piedi si è veloci come i buoi.. Obelix: Per forza! Anche i buoi sono a piedi.(Asterix e il Falcetto d’oro).
Parafrasando Goscinny, uno dei migliori osservatori della società europea del dopoguerra, mi viene da dire che “il cavallo va a cavallo da quando è nato”.
Da questa apparente ovvietà discende quella che è l’essenza dell’equitazione moderna, secondo cui il cavaliere deve adattarsi in modo da trovare l’equilibrio ottimale del binomio cavallo-cavaliere, così da intralciare il meno possibile il cavallo mentre esegue le indicazioni del che il cavaliere gli ha trasmesso.
Si tratta di una frase densa di concetti che è bene sviscerare:
1. E’ il cavaliere che deve adattare il proprio equilibrio a quello del cavallo. Qui si parla di equilibrio nel senso fisico del termine, perchè ogni cavallo ha un suo baricentro, che cambia alle diverse andature (passo, trotto, galoppo) ed è quindi il cavaliere che deve regolare il proprio assetto in modo che il nuovo baricentro complessivo (cavallo+cavaliere) sia ugualmente efficace come quello naturale del cavallo da solo.
2. Il nuovo equilibrio sarà comunque diverso da quello naturale del cavallo. Questo per sottolineare la necessità che il cavaliere prenda coscienza del fatto che deve essere lui a portare il binomio a trovare questo nuovo equilibrio. Il cavallo stava bene anche da solo.
3. il “valore aggiunto” del cavaliere è la sua volontà. Come sa benissimo qualsiasi cavaliere principiante (come me), il cavallo da solo trotta, galoppa, si ferma, si gira e salta molto meglio da solo che con qualcuno sopra. Il contributo del cavaliere quindi sta essenzialmente nel definire quando e con quanta intensità fare queste cose (nel caso ci fossero degli esperti di equitazione tra i lettori specifico che probabilmente le considerazioni di questo post non valgono nel caso di dressage, alta scuola e similia).
Ed eccoci arrivati al punto centrale: come fare a trasmettere al cavallo la propria volontà? Escludendo la forza, non solo perchè poco etica e quindi poco estetica, ma soprattutto perchè poco efficace, trattando con animali che pesano 400-600 kg, è necessario utilizzare la tecnica.
Senza voler fare un trattato di equitazione (anche perchè non ne sarei asoslutamente in grado), il cavaliere dispone di una serie di aiuti per trasmettere al cavallo addestrato le proprie intenzioni attraverso la voce, le mani (che tengono le redini), le gambe (che fasciano il costato del cavallo), il frustino, la voce e l’assetto (ossia la dislocazione del proprio peso in modo da interagire con l’equilibrio del cavallo). Perchè siano efficaci questi aiuti vanno utilizzati insieme in modo coordinato e coerente e vanno interrotti appena il cavallo capisce cosa vogliamo da lui ed inizia a farlo.
Gli errori nell’uso degli aiuti si dividono quindi sostanzialmente in due categorie:
a) Utilizzo confuso e/o contradditorio degli aiuti: se con la pressione delle gambe indico al cavallo l’intenzione di andare a destra, ma con la posizione delle mani gli indico di andare e sinistra è molto probabile che il cavallo non sappia cosa. Il problema è meno ovvio di quello che sembra perchè l’uso degli aiuti non è meccanico e quindi non è sufficente sapere in teoria quali sono i giusti movimenti e qual’è la giusta sequenza. Bisogna utilizzarli con il giusto equilibrio, che è una cosa quasi più inconscia che razionale. Ecco perchè, ad esempio, verrà molto più naturale fare i movimenti giusti (spostamento dell’assetto, ossia dell’equilibrio, compreso), se quando vogliamo girare guarderemo nella direzione in cui vogliamo andare (per inciso anche in moto le curve vengono meglio se si guarda l’uscita della curva anzichè davanti alla propria ruota).
b) eccessiva intensità e durata nell’utilizzo degli aiuti. Nuovamente, il cavallo non è una macchina, prima di eseguire un comando deve capirlo. E’ quindi necessario che il cavaliere utilizzi gli aiuti con il necessario anticipo e che dia il giusto tempo al cavallo per agire di conseguenza. Se voglio che il cavallo si fermi, stringo i pugni, porto indietro le spalle e spingo in basso i talloni per scendere nell’inforcatura. Se non mi sono dimenticato niente ed ho fatto tutto bene, il cavallo farà ancora alcuni passi e poi si fermerà. A questo punto riprendo l’assetto normale per far capire al cavallo che ha fatto quallo che gli avevo richiesto.
Nel caso in cui l’intesità degli aiuti sia eccessiva o questi vengano utilizzati dal cavaliere anche dopo che il cavallo ha eseguito la richiesta, non è che il cavallo ubbidisca di più, anzi diventerà sempre più “sordo” agli aiuti, che dovranno essere sempre più intensi, fino a quando anche “appendersi” alla bocca del cavallo non servirà più a niente. E’ un circolo vizioso concettualmente simile al problema di “bruciare il comando” visto nei post precedenti relativamente all’addestramento dei cani.
I due tipi di errori tendono a sommarsi, nel senso che io sbaglio nell’uso degli aiuti, il cavallo non fa quello che mi aspetto e quindi io aumento l’intensità delle mie azioni (sbagliate). Il risultato è che il cavallo disimpara quello che sapeva fare. Già questo sarebbe sufficiente a mettere in guardia sulla necessità di non eccedere nella gestione dei propri collaboratori, ma c’è un rischio ancora maggiore che si evidenzia andando a cavallo ed è quando MALGRADO gli errori del cavaliere. il cavallo fa la cosa giusta.
Come già detto più volte, il cavallo non è una macchina, ma un essere vivente, pensante con una sua intelligenza ed emotività individuale (nel senso che ogni cavallo e diverso dagli altri), che sa già fare naturalmente quello che noi gli chiediamo di fare, e per di più è stato addestrato per farlo. Quindi succede più spesso di quanto non si immagini che il cavallo esegue comunque la richiesta del cavaliere, anche se questa è stata comunicata male o con eccessiva forza.
In questo caso quello che disimpara non sarà il cavallo, ma il cavaliere che, convinto che il risultato positivo sia conseguenza delle sue azioni e non dell’intelligenza e della buona volontà del cavallo, persevererà nella cattiva/eccessiva gestione.
Mi rendo conto che questo post risulta un po’ più farragginoso del solito e la cosa non mi stupisce perchè, a furia di rimandarlo, era in bozza da più di un mese. Ad un certo punto il tempo diventa eccessivo ed i concetti si avviluppano su se stessi. Risparmierò quindi i paralleli tra la gestione del cavallo e quella del personale, anche perchè mi sembrano evidenti.
Se c’è qualcosa di veramente incomprensibile, spero che venga fuori nei commenti così da poterlo chiarire.
Con questo post concludo il parallelo tra gestione del personale ed etologia. Spero che nessuno si sia sentito offeso, soprattutto tra i miei passati e presenti collaboratori. Se è così posso scusarmi e sottolineare una volta di più che non era questa l’intenzione.
Concludo dedicando questo post a tre cavalli in particolare:
- Darius: che facendo finta di zoppicare quando lo montavo io, mi ha fatto capire l’importanza dell’individualità.
- Pedro: così generoso da perdonare spesso i miei errori, ma unico cavallo, ad oggi, a farmi volare per terra, facendomi capire con chiarezza animale che non bisogna abusare della disponibilità altrui.
- Dominique: che esige di essere montata bene, altrimenti non si muove, sgroppa, scalcia e così mi costringe ad impegnarmi sempre al massimo.
Le 10 bugie di Berlusconi secondo “la Repubblica” 12 aprile: chi semina vento raccoglie tempesta.
Lo so che i miei affezionati lettori aspettano il post sul cavallo, però oggi sono andato a Milano in treno e così mi hanno offerto un giornale; con la prospettiva di oltre 4 ore di viaggio ho preso la Repubblica.
Premetto che leggo sempre meno i giornali, li sfoglio per abitudine, ma leggerli proprio non mi riesce perchè … non c’è scritto niente. Dopo aver letto i titoli, le disdascalie sotto le foto ed i titoletti inseriti all’interno degli articoli, non resta molto di più negli asfittici articoli dei giornali moderni, schiacciati da riduzione del formato e pubblicità.
Confesso che non ho mai amato “la Repubblica” malgrado sia in un certo senso il giornale della mia generazione (quest’anno faccio 48 anni) ed ho smesso di comprarla da quando, credo fosse il 1987, dedicò un’articolo a pagina intera (e quella volta le pagine avevano più testo che grafica) al matrimonio di Pippo Baudo, deridendo in ogni frase l’atmosfera nazional-popolare della cerimonia e della festa seguente. O ritieni che la notizia sia interessante, e allora fai un reportage serio, oppure ritieni che per la tua linea editoriale non lo sia, linea editoriale che condividevo, e allora fai un trafiletto proprio per non vivere fuori dal mondo. Ma andare per metterlo alla berlina per il kitch in ogni angolo è disonestà intellettuale: Cosa ti potevi aspettare dal matrimonio di Pippo Baudo?
io leggevo il giorno (ci scriveva Gianni Clerici, poi passato a Repubblica) e la Stampa (Curzio Maltese e Berbara Spinelli anche loro passati a Repubblica, per citarne solo due).
Oggi però tra Corriere e Repubblica ho preso la seconda. Arrivato a pag. 4 ho trovato le 10 bugie di Berlusconi riguardo al processo Ruby (sul web non le trovo per linkarle, dovrete darvi da fare voi). Un trafiletto dove si in prosa “poliziese” si trovano cose tipo B.dice “E’ la 28esima persecuzione giudiziaria”. Il numero è inesatto. Berlusconi ha subito 16 processi (tre le assoluzioni) oppure B. dice “hanno violato la mia casa”. E’ falso. Le indagini si sono fermate al cancello di Arcore. Le altre sono più o meno su questa linea, ossia capziose (che siano 28 oppure 16 il concetto non cambia, sono comunque tante) e basate più sulla forma che sulla sostanza. Soprattutto le risposte del giornale implicano già una sentenza, mentre ilo dibattimento è appena cominciato. Niente di male che la redazione di Repubblica sia già convinta della colpevolezza di Berlusconi, però poi non si può pretendere così di rappresentare una voce equilibrata, in grado di porre delle questioni nella società. In realtà dubito che ci sia nessuno in Italia che creda che Berlusconi abbia pagato Ruby per NON farla prostituire, oppure che potesse davvero credere che fosse la nipote di Mubarak (affermazione che tra l’altro implica dare degli incompetenti totali ai nostri servizi di intelligence). Il punto è quanti sono gli elettori per i quali questi comportamenti sono politicamente irrilevanti (gli aspetti giudiziari, riguardano innazitutto i tribunali).
Se poi questo atteggiamento è una risposta all’agghiacciante e ributtante linea editoriale del Giornale, beh non funziona e serve invece solo ad alimentare e rafforzare l’ipotesi della persecuzione.
Come dice il proverbio riportato nel titolo: chi semina vento, raccoglie tempesta, e nella tempesta i capitani pavidi dell’ opposizione continuano a perdersi.
Sempre più grande il rimpianto per Prodi che con la credibilità della competenza e l’azione (di sostanza) invece della reazione (di forma) ha vinto due elezioni.
La prossima volta parlo di Dominique, promesso.
AMA quote of the day
“A business absolutely devoted to service will have only one worry about profits. They will be embarrassingly large.”
- Henry Ford
Gestione del personale ed etologia 3
Un’appendice all’ultimo post di argomento cinofilo per ricordare la terza lezione che ho imparato durante il corso di addestramento dei miei due cani (come detto all’inzio dall’addestratore il corso riguardava tanto loro quanto noi).
Si tratta del concetto di evitare “bruciare il comando”, insistendo negli ordini senza che vengano eseguiti oppure mentre vengono eseguiti, ed è particolarmente interessante perchè, al contrario di quelli del post precedente, è un concetto contro-intuitivo.
In pratica significa che che gridare “vieni-vieni-vieni-vieni ……” mentre il cane chiamato sta ubbidendo e venendo verso di noi non rafforza il comando, ma anzi lo indebolisce. Quante volte a voi umani è successo che venissero a controllare per assicurarsi che steste svolgendo il compito che vi era stato affidato poco prima? Vi siete sentiti motivi o avete percepito un senso di sfiducia? Ecco, con i cani è lo stesso.
Quanto più si ripete un comando e tanto più questo si banalizza alle orecchie del cane. Questo è anche il motivo per cui il cane va chiamato con il suo nome solamente per le cose importanti, mentre nelle altre occasioni è meglio utilizzare pseudonimi o termini generici a scelta. Per mantenere forza il nome non va inflazionato (un po’ lungo da spiegare a tutti quelli che come prima quando si fermano ad accarezzare il cane chiedono come prima cosa “Come si chiama?”).
Collegato a questo concetto c’è quello di evitare di continuare di dare un’ordine se non siamo nelle condizione di farlo sicuramente eseguire dal cane al terzo, massimo quarto comando, perchè in questo caso il comando rischia di bruciarsi ancora più rapidamento. Ad esempio se dò il comando di seduto e lui non lo fa, alla terza volta devo intervenire fisicamente e mettere il cane seduto (niente di violento, basta premergli in giù il sedere).
Da questo ne discende che devo dare al cane ordini che è in grado di sentire, comprendere ed eseguire. In latre parole l’addestramento deve essere graduale, i comandi chiari e semplici e dati solo quando abbiamo l’attenzione del cane. Dal mio corso di caporale mi torna in mente la definizione per cui la consegna deve essere “precisa, coincisa e tassativa”; sostituendo “tassativa” con “condivisa”, mi sentirei di sottorsciverlo.
Riassumendo se voglio chiamare il mio cane che sta gironzolando per il prato la sequenza è:
- ottenerne l’attenzione con un richiamo o al limite chiamandolo per nome;
- dare il comando “vieni”;
- aspettare per vedere se il cane si muove verso di me, viceversa ripetere il comando;
- avere la pazienza di aspettare che arrivi;
- premiarlo con un “bravo” quando arriva da me perchè ha ubbidito.
Anche se non lo trovo nei post vecchi, ho la sensazione di aver già scritto questo aneddoto. Se è così chiedo perdono per la ripetizione.
Quando avevo 14 anni giocavo a pallacanestro nella squadra di Spinea (per dare un’idea di quante cose siano cambiate basta dire che eravamo l’unica squadra a giocare in una palestra, tutte le altre avevano solo campi all’aperto. Oggi sembra incredibile, ma vi assicuro che ho giocato partite di basket sospese per pioggia e per neve) e la miglior squadra del girone era lo Zelarino, il cui allenatore non smetteva di gridare indicazioni ai suoi giocatori per tutti i 40 minuti.
Visti i risultati credevo fosse una tecnica vincente. Tre anni dopo mi sono trovato a fare un provino per le giovanili della gloriosa Reyer Venezia, allora in serie A, e sul sacro parquet dell’Abazzia della Misericordia (chiesa sconsacrata dove si giocava tra gli affreschi del Sansovino) mi sono allenato per tre mesi con un giocatore proprio dello Zelarino. Quando gli ho chiesto come faceva a seguire quel continuo flusso di istruzioni mi ha tranquillamente risposto che non gli davano alcun fastidio perchè dopo i primi cinque minuti nessuno dei giocatori ascoltava più quell’(esaltato) allenatore che si sgolava a bordo campo.
Questo è lo spunto per riflettre sul corretto dosaggio di intervento nei confronti delle persone di cui si ha la responsabilità. Ma su questo argomento il grande maestro è il cavallo, che sarà l’animale protagonista del prossimo post.
A dopo il Vinitaly (se volete passare a trovarmi, lo stand Santa Margherita è nel padiglione 4).
AMA quote of the day
“Hard work spotlights the character of people: some turn up their sleeves, some turn up their noses, and some don’t turn up at all.”
- Sam Ewing
AMA quote of the day
“Informed decision-making comes from a long tradition of guessing and then blaming others for inadequate results.”
- Scott Adams
AMA quote of the day
“Creative minds have always been known to survive any kind of bad training.”
- Anna Freud
AMA quote of the day
“Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day.”
- Jim Rohn
Il web 2.0, l’eccesso di informazioni ed il peggioramento delle decisioni.
Nell’ultimo numero dell’ “Internazionale” un articolo su come l’eccesso di nformazioni peggiora efficacia ed efficenza dei processi decisionali. consigliatissimo:www.internazionale.it/sommario
Gestione del personale ed etologia 2
Io ho due cani, per la precisione un maschio ed una femmina, per maggior precisione Fly e Kali (abbreviativo di Kalimera o Kalimocho, a piacere). Fly è quello marrone, Kali è quella bianca.

Fly l’abbiamo preso dal canile che aveva circa 6 anni, mentre Kali l’abbiamo comprata in allevamento che aveva 5 mesi, un po’ perchè un cane così da adottare non riuscivamo a trovarlo ed un po’ per fare compagnia a Fly, che aveva crisi di ansia di abbandono piuttosto forti. La cosa aveva in parte funzionato, ma, comunque, sei mesi dopo all’arrivo della primavera abbiamo deciso di fare una serie di lezioni di addestramento/comportamento (tanti anni fa per un periodo giravo con in tasca biglietti da visita di un centro di addestramento per cani di un amico e quando avevo a che fare con persone particolarmente maleducate gliene davo uno dicendo “non pretendo l’educazione, ma magari almeno un minimo di addestramento”).
Le lezioni sono state utili ed istruttive per trattare meglio i cani e stimolanti per riflettere sui paralleli con il comportamento tra gli umani. La cosa non è per niente nuova, tanto che è stata persino utilizzata nella sceneggiatura di una piacevolissima commedia con Sandra Dee: “Una sposa per due”.
Ma veniamo alle lezioni.
- Prima lezione: prova di affezione. In un spazio aperto il cane viene trattenuto dall’addestratore mentre il padrone si allontana e si nasconde, in modo che il cane non possa più vederlo. Quando il padrone è nascosto il cane viene rilasciato, libero di fare quello che vuole. Se esiste un rapporto forte, il cane andrà dritto alla ricerca del padrone annusando il terreno, se è debole girerà intorno per il prato, se è conflittuale andrà in giro tranquillamente per il prato a quando trova il padrone gli farà la pipì sui pantaloni (se maschio). Poichè tutti siamo convinti di essere amati dal nostro cane, consiglio di fare la prova solamente se ci si sente moralmente pronti ad accettare il peggio. E’ me è andata così-così nel senso che ho dovuto chiamarli un paio di volte prima che decidessero di venire a cercarmi invece di inseguire le farfalle. A detta dell’addestratore non malissimo, considerando che avevamo i cani da 6-8 mesi. E qui ho imparato la mia prima lezione: per stabilire un rapporto con un essere vivente ci vuole del tempo ed è necessario aver condiviso una serie di esperienze insieme. Ovvio direte voi, certamente rispondo io. Ed in effetti tutto quello che scriverò in questo post è ovvio a posteriori, a voi il compito di riflettere su quante volte questi ovvi comportamenti si manifestano nei vostri rapporti quotidiani con le persone (sul luogo di lavoro e non).
Seconda lezione: il cane è un animale gerarchico nel senso che si colloca in un ordine ben preciso all’interno del branco e per gestire il cane con tranquillità nostra e sua, il padrone/i padroni devono essere in cima alla scala gerarchica perchè gli ordini del capobranco riconosciuto vengono seguiti con serenità. Il punto è come fare ad essere riconosciuti come capobranco. Fra le varie cose da fare c’è anche quella di premiare i comportamenti positivi e condannare quelli negativi, senza mai usare punizioni fisiche perchè in questo caso il cane temerà il padrone e quindi ubbidirà solo perchè “costretto”, ma, soprattutto, sarà sempre in ansia. in altre parole invece della serenità che gli viene dalla consapevolezza di avere una guida da seguire, sarà in ansia per la necessità di ubbidire. Aggiungo, cosa importante, che il cane in ansia fa più fatica a capire cosa gli viene richiesto e quindi cosa ha sbagliato e quindi a correggersi.
In sentesi la buona vecchia differenza tra autorità ed autorevolezza.
E qui è stato divertente, perchè l’addestratore si era raccomandato di portare qualcosa di buono con cui premiare i cani e noi avevamo portato un confezione di wurstel, che Fly e Kali snobbavano alla grande. E’ che rispetto alla cena di crocchette mescolate con la carne macinata che mangiavano tutti i giorni, non è che fossero particolarmente appetitosi. Ricordo però che la cena succulenta non li rendeva comunque particolarmente affezionati ai loro padroni (vedi sopra). Decisione dell’addestratore: da quel giorno, per tutto il periodo di addestramento, solo crocchette nella ciotola e le leccornie esclusivamente come premio.
Altra attività che rafforza il rapporto cane.padrone è il gioco, che ha anche una forte funzione premiante, tanto più quanta più voglia di giocare ha il cane. Quindi nell’addestramento è importante non giocare ad oltranza, ma smettere quando il cane ha ancora voglia. E qui credevo di aver imparato la mia seconda lezione, nel senso che se io sono quello che decide quando si mangiano le cose buone e quando ci si diverte, è ovvio che sono il capo, ma non c’è un gran merito.
Credevo, perchè in realtà vanno evitati gli automatismi, il cane infatti non è mona (come si direbbe a casa mia) ed il confine che passa tra il rinforzo positivo della
Ecco perchè si comincia con le più facili ricompense tangibili (leccornie) per arrivare poi a quelle intangibili (carezze, complimenti, ecc) raggiungendo, quanto meno, una “moral suasion”. Vi assicuro che dopo 6/7 lezioni la prova di affezione era un’altra cosa.
Come dicevo all’inizio, il parallelo tra l’addestramento cinofilo ed i rapporti tra le persone non sono niente di nuovo e mentre facevo questo ciclo di addestramento mi è tornata in mente la considerazione di una mia collega in Stock (era entrata nel 1972 e quindi ne aveva viste di tutti i colori) quando si parlava di corsi di formazione del middle e top management per la gestione del personale “Mi ricordo quando qualche anno fa anno mandato i direttori in “collegio” allo studio Ambrosetti”. io chiesi “In che senso in collegio?” “Nel senso che sostanzialmente quello che gli hanno insegnato al corso è stato chiedere per piacere e a dire grazie. Peccato che tempo un mese se ne erano già dimenticati”.
Come dicevo all’inizio: se non educazione, almeno un minimo di addestramento.
AMA quote of the day
“Courage can’t see around corners, but goes around them anyway.”
- Mignon McLaughlin
Gestione del personale ed etologia – 1
Premessa n.1: questo è il primo di alcuni post sull’argomento (me ne frullano in testa altri 2).
Premessa n.2: il titolo potrebbe essere stato più efficacemente “leadership ed etologia” perchè per me “leadership” è un sinonimo di “gestione del personale”, però così mi sembrava più chiaro.
Premessa n.3: alcuni dei concetti che scriverò li ho già usati nel mio lavoro e quindi so che c’è il rischio che qualcuno si offenda ad essere paragonato ad un animale. Chiedo scusa fin da subito e segnalo che i centri emotivi del cervello sono tra le parti più antiche dell’organo (se non ricordo male). E comunque Desmond Morris l’ha detto molto prima e molto meglio di me.
La mia conoscenza di alcuni concetti di etologia proviene dagli studi di produzione animale. Da molti anni quindi ho utilizzato uno dei più elementari relativamente al comportamenti dei gruppi sociali.
Esempio 1: ogni scrofa (termine tecnico) partorisce 8-10 suinetti per volta e questi vengono svezzati dopo 4 settimane, unendo due nidiate. Nei primi due giorni dopo che sono state unite le due nidiate si assiste ad una perdita di peso dei suinetti semplicemente perchè smettono di mangiare. E smettono di mangiare perchè sono impegnati a ristabilire le gerarchie all’interno del nuovo gruppo.
Esempio 2: nell’allevamento di vacche (anche questo è un termine tecnico, ho visto uno studente sotto esame perdere due punti per aver detto “mucca”) da latte a stabulazione libera (significa che non sono chiuse in stalla, ma girano libere all’interno del recinto) bisogna evitare mandrie superiori ai 40 capi perchè oltre questo numero non si riescono a stabilire gerarchie chiare all’interno della mandria e quindi la produzione di latte si riduce. Detto in altri termini gli animali sono continuamente in tensione per stabilire una scala gerarchica, che non riesco però a fissare a causa dell’eccesso di interazioni che devono gestire. E l’animale stressato produce meno, sia perchè mangia meno sia perchè consuma energie nervose nella gestione dei rapporti sociali.
Tanti, tanti anni fa, quando ero bambino, il jingle della pubblicità dei formaggini Milkana (mai mangiato uno) diceva “dove il pascolo è più alto, l’erba è verde-verde-verde, dove l’erba è verde-verde-verde c’è la mucca più felice, se la mucca è più felice è migliore anche il suo latte. Beh, forse i creativi di quella volta avevano in mano delle ricerche o magari gli è semplicemente piaciuto il concetto, però è assolutamente e scientificamente vero! Da qui potrei partire un una lunga digressione sulla gestione dell’allevamento di vacche da latte, e come questa sia più efficace quando in stalla ci sono delle donne, ma cerco di mantenermi nell’ambito del marketing.
Ricordo lo stupore e l’ilarità di alcuni colleghi quando raccontavo l’esempio delle vacche da latte (anche se so che il mio amico Michael Kennedy della Drambuie ne è rimasto talmente colpito da diffonderlo).
Immaginatevi il mio stupore quando 7 anni fa, quindi molto dopo la mia laurea in produzioni animali, ad un corso internazioanle sulla gestione dei gruppi di lavoro mi hanno spiegato che un gruppo di persone passa per 4 fasi: FORMING – STORMING – NORMING – PERFORMING.
Senza offesa per nessuno mi chiedo: cosa c’è di diverso rispetto al gruppo di lavoro della vacche da latte?
Una differenza c’è e sta nelle sovrastruttura delle convezioni sociali che abbiamo noi umani, e che (probabilmente) manca negli animali.
Mi spiego: quando si mette insieme un gruppo di animali (forming) questi naturalmente si confronteranno (storming), definiranno le scale gerarchiche confrontandosi sui comportamenti (norming) ed a questo punto potranno produrre un risultato (performing).
In un gruppo umano manca l’automatismo e la relazione diretta tra intenzioni e comportamento. E’ quindi cruciale creare nel gruppo la serenità necessaria perchè la fase di storming sia la più completa ed approfondita possibile, evitando di lasciare zone d’ombra o come si dice in inglese “girando tutti i sassi”. Viceversa il norming che ne scaturisce non riuscirà a contemplare tutte le situazioni ed aspettative, mettendo a rischio il performing.
L’altra differenza tra i gruppi animali e quelli umani è che nei primi il leader viene identificato attraverso un processo di confronto spontaneo e naturale mentre nei secondi viene nominato formalmente. Poichè confrontarsi all’interno di un gruppo ha sempre un costo emotivo, non è detto che la fase di storming si sviluppi con la necessaria chiarezza e completezza per passare efficaciemente a quello successive. Ecco perchè questo rischio va ridotto creando la massima serenità all’interno del gruppo per minimizzare il costo emotivo del confronto.
Nel prossimo post spazio ai (miei due) cani.
Marketing marketing myopia
Non è che nella fretta ho scritto male il titolo e non me ne sono accorto. E’ che il post di oggi è sulla miopia di marketing che affligge il marketing.
Spiego: il concetto di miopia di marketing (in inglese “marketing myopia“) descrive quel fenomeno per cui le aziende/funzioni marketing perdono delle opportunità di mercato perchè non vedono al di là del proprio naso.
E’ un concetto che mi ha sempre affascinato per la sua facile ed immediata comprensibilità, immagino dovuta al fatto che ero miope (oramai con l’età sono passato alle bifocali) e che l’assonanza con l’italiano mi permise di capirlo all’inizio dei miei studi di marketing canadesi (quando l’inglese era ancora molto maccheronico).
Però non l’avevo mai pensato associato al ruolo della funzione marketing in generale. Lo spunto però mi è venuto ad un convegno sull’ecosostenibilità nel settore del vino a cui mi hanno gentilmente invitato a parlare.
Diversi altri relatori hanno sottolineato come sull’argomento ecostenibilità sia necessaria una maggiore e migliore comunicazione (più chiara, precisa, credibile, autorevole) e QUINDI sia necessario andare oltre il marketing.
Attenzione, non si diceva che il marketing deve (tornare ad) avere maggiore credibilità. Si diceva che per avere credibilità bisogna liberarsene tout-court.
Credo sia chiaro come sia oramai cosciente dell’associazione marketing=propaganda che permea la società civile, ma che nessuno vede la contraddizione di chiedere più comunicazione ed allo stesso tempo estromettere i professionisti nel realizzarla comunque mi stupisce ed un po’ mi dispiace.
Perchè professionisti del marketing e della comunicazione non ci si improvvisa e se una comunicazione efficace non si può fare con il marketing, perchè manca di etica e credibilità, non si può fare nemmeno senza quel mix di competenze di targeting, positioning, consumer behaviour, semantica e semiotica che contraddistinguono i professionisti del marketing (per una volta ho usato i termini inglesi come quelli veri).
Chiudo con una considerazione organizzativa: non sarebbe ora che il marketing diventasse una posizione di staff invece che di linea?