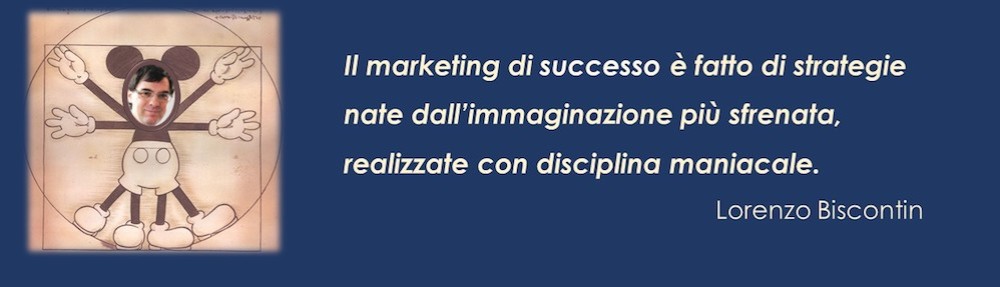Sfogliando la stampa specializzata del settore bevande nell’ultimo mese non si poteva fare a meno di noatre le pubblicità di alcune novità di prodotto: Bacardi Originals, Bacardi Pina Colada+Bacardi Mojito e Pampero Mojto alla spina (qui il link non è al sito del Pampero, già difficile da trovare di suo, perchè lì questo prodotto non è citato).
Sono prodotti che mi hanno fatto pensare al fenomeno dei ready to drink dei primi anni 2000. Immagino che più di qualcuno si ricorderà dei vari Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, Campari Mixx ed Havana Loco. Si trattava di long drinks a base di superalcolico (vodka, rum, campari a seconda dei casi) e di acqua gassata apparsi sul mercato a partire circa dal 2002 e sostanzialmente spariti per il 2005. Nessuno di questi è riuscito a consolidarsi sul mercato e, malgrado i volumi sviluppati siano stati molti importanti grazie ai fortissimi investimenti pubblicitari delle aziende, nel milgiore dei casi il business ha raggiunto il breack-even o poco più.
Era un segmento che avevo analizzato a fondo perchè nel 2003 in Stock eravamo pronti a lanciare due ready to drink a marchio Keglevich (definite e testate ricette e packaging, definiti gli accordi con gli imbottigliatori, ecc..), quando poi abbiamo deciso di non schiacciare il bottone del via. Esperienza, competenza, fortuna o presunzione? Non l’ho mai capito, ma è andata bene così. Secondo me il punto debole della categoria stava nel concetto stesso di prodotto che non era nè una bibita gassata, visto il circa 5% di grado alcolico, nè aveva la qualità di un long drink preparato sul momento, sia intrinsecamente che di immagine (percezione di “beverone” industriale). Inoltre non si basavano su long drinks affermati, ma proponevano sostanzialmente gusti nuovi per il mercato dei long drinks (il capostipite Smirnoff Ice era vodka con leggero gusto di limone, stessa base limone del principale Bacardi Breezer).
Riusciranno le proposte dell’estate 2011 ad avere il successo che non hanno avuto i ready to drink di qualche anno fa? Hanno dalla loro la proposta di long drink classici e molto richiesti (mojito in primis) e la praticità per il trade che deve servirli.
Io però dubito che la valutazione fatta dal consumatore (che ricordiamo sempre sono persone) a suo tempo sarà molto diversa oggi. E’ vero che nelle discoteche e nei locali di grande afflusso è prassi normale oramai da alcuni anni quella di preparare la basi per i long drinks più richiesti, ma c’è comunque una forte componente di intervento del bartender al cui confronto la spina di mojito Pampero mi sembra francamente agghiacciante.
In realtà credo che possa esistere una terza via, che hai tempi avevo proposto in Stock senza successo, ed è quella del facilitare la preparazione di cocktails e long drinks nel consumo in casa. Il numero di persone che per motivi generazionali di ciclo di vita sta riducendo o annullando aperitivo/happy hour/serate fuori casa comincia ad essere rilevante.
Il fatto che queste persone abbiano dovuto cambiare il loro stile di vita riguardo alla frequentazione dei locali non significa che vogliano cambiare anche gli stili di consumo, però preparasi cocktails e long drinks a casa può essere complicato, soprattutto se si tratta di situazioni “sociali” in cui sono presenti più persone.
Una riposta a questa esigenza attualmente insoddisfatta mi era stata ispirata da E’ un concetto che avevo preso da una confezione di Tequila Sauza comprata in un duty free: nell’astuccio c’era una bottiglia da 1l di tequila ed una da 1l di margarita mix, totalmente analcolico. Idea intelligente, però era stata pensata come promozione tattica a se stante e non come innovazione strategica. Il risultato dell’esperienza di consumo era quindi deludente, non per la qualità del cocktail che ne derivava, ma perchè seguendo la proporzione consigliata di 1/3 tequila e 2/3 margarita mix, il mix finiva prima del tequila, per cui, a meno di non darsi agli shoot (ma è un consumo da tutt’altro target) uno rimaneva con del tequila di cui non sapeva che farsene.
Da qui la mia idea di produrre e vendere basi per per cocktails e long drinks come categoria a sè (se poi il lancio avesse previsto confezioni in co-pack con il distillato era un tecnicismo), prevedendo che avessero tutti gli ingredienti necessari, anche quelli alcolici, se del caso. Per rimanere all’esempio del margarita mix, quello che volevo fare io prevedeva al suo interno anche la giusta % di Triple Sec, che è il nome del distillato generico fatto con lo stesso processo del Cointreau (ingrediente ufficiale del Margarita).
In questo modo si ottenevano due obiettivi: si forniva al consumatore un prodotto con cui poteva realizzare un cocktail assolutamente fedele a quello che avrebbe preparato un bartender e, dal punto di vista dell’azienda, si aggiungeva una modalità di vendita del triple sec.
Non c’è la praticità del ready to drink, ma c’è l’autenticità del coinvolgimento diretto del consumatore nella preparazione (semplificata) che gli permette di aggiungere il suo tocco e di variare le proporzioni a suo gusto.
Magari prima o poi riuscirò a realizzarla ed a scoprire se era veramente un bel concetto strategico o solo un’alzata d’ingegno.
Category Archives: Blog
BOSCO VITICOLTORI ASSOCIATI AFFIDA LA DIREZIONE GENERALE A LORENZO BISCONTIN.
Non è che parlo in terza persona perchè sono diventato come Cesare negli Asterix.
E’ che Lorenzo Biscontin come autore di biscomarketing e Lorenzo Biscontin come professionista sono due cose, ovviamente, affini, ma non coincidenti (Pirandello al confronto non era nessuno).
Quindi, visto che oggi è partito il comunicato stampa, mi è sembrato giusto riportarlo (quasi) asetticamente come un mezzo di comunicazione qualsiasi. Lo trovate qui sotto.
A questo punto per tornare a parlare di vino dovrò aprire un blog apposta.
Comunicato stampa
BOSCO VITICOLTORI ASSOCIATI AFFIDA LA DIREZIONE GENERALE A LORENZO BISCONTIN.
Lorenzo Biscontin è il nuovo Direttore Generale della cantina Bosco Viticoltori Associati.
Veneziano d’origine, ma oramai triestino di adozione, ha occupato posizioni con responsabilità crescenti nel marketing di aziende italiane del settore agro-alimentare, sia a livello nazionale che internazionale.
Dopo la laurea in Scienze delle Produzioni Animali e le successive specializzazioni e masters in marketing e gestione aziendale del comparto food & beverage, ha iniziato a lavorare nel settore dei salumi, per spostarsi poi nei vini e liquori.
Come Direttore Marketing in Stock ha gestito la crescita di marche quali Limoncè e Keglevich, per poi passare nel 2007 a coprire la stessa posizione presso Santa Margherita Gruppo Vinicolo, realizzando il rinnovamento del posizionamento di immagine e di assortimento delle diverse cantine del Gruppo.
Alla Bosco Viticoltori Associati porta la sua ventennale esperienza nello sviluppo e gestione di marchi leader.
Bosco Viticoltori Associati è di proprietà della Gruvit S.r.l., a sua volta partecipata al 50% dalle Cantine Produttori Riuniti del Veneto Orientale ed al 50% dalla Cantina Produttori Campo di Pietra. Un polo vinicolo a cui appartengono oltre 2.000 soci viticoltori che nel 2010 hanno conferito oltre 500.000 q.li di uva e che ha sviluppato un fatturato di 45 milioni di euro.
Bosco Viticoltori Associati con i suoi 15 milioni di euro di fatturato rappresenta la punta avanzata di Gruvit nel mercato del vino in bottiglia.
“La responsabilità della gestione dell’intera azienda è per me un’esperienza nuova, che affronto sulla base di quella che è sempre stata la mia interpretazione del marketing come funzione integrante di tutte le fasi aziendali. Oggi le dimensioni del Gruppo ne fanno uno degli operatori di riferimento nella vitivinicoltura del Veneto Orientale: l’obiettivo è di farne crescere anche il ruolo strategico nella valorizzazione di un territorio dove da sempre il consumo di vino è parte della cultura quotidiana”, dice il nuovo Direttore, Lorenzo Biscontin.
Per il Vice Presidente di Gruvit, Signor Ircano De Lucca “… con il contributo del dottor Biscontin puntiamo a sviluppare ulteriormente la nostra crescita sul mercato nazionale e su quelli internazionali per accelerare ulteriormente il trend che nel primo trimestre 2011 ci vede crescere del 9% a volume e del 31% a valore”
Il prosecco spinge biscomarketing oltre al tetto delle 100 visite in un giorno
Questo blog viaggia normalmente tra le 25-30 visite al giorno.
Lo scorso 1 luglio, quando ho pubblicato il post sul prosecco, è schizzato a 133, mantenendosi tra 40 e 50 fino al 4 di luglio per tornare in media nei giorni successivi. Ancora più netto l’aumento dei commenti.
Sono numeri che invitano tutti coloro che si occupano di comunicazione di vino a riflettere sulla quantità e qualità del seguito che suscita l’argomento vino nel web.
Che siano anche un’ulteriore dimostrazione del successo di questo vino?
Quanto a me, forse dovrei cominciare a pensare di aprire un blog sul vino.
Anche ad Asolo il Prosecco è Superiore
Detto senza malizia, sapevo che scrivendo un post di marketing che riguardava il vino mi sarei cacciato in un vespaio.
Luca Ferraro dell’azienda Bele Casel mi fa notare che nel 2009 anche il prosecco di Asolo è passato alla DOCG ed alla dicitura Superiore. Lo riporto volentieri per completezza di informazione, anche se il post odierno precedente non aveva l’obiettivo di descrivere compiutamente la situazione normativa del prosecco DOC/DOCG, quanto le problematiche del posizionamento della DOCG rispetto alla DOC.
Tutte le considerazioni fatte per la DOCG Conegliano-Valdobbiadene (in realtà i due termini si possono anche utilizzare separatamente e questo è evidentemente un altro elemento di debolezza per una chiara e forte comunicazione del marchio, ma come detto, i dettagli nella normativa del vino sono talmente tanti che si rischia di perdere l’essenza dei problemi) valgono pari pari anche per l’Asolo DOCG, solamente su scala più ridotta.
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE: dove il Prosecco è Superiore.
Regola editoriale non scritta, ma reale, del mio blog è non scrivere del settore in cui lavoro, per rispetto dei colleghi che lavorano nelle altre aziende, per evitare l’eventuale confusione tra opinioni personali diverse dalla posizione definita aziendalmente, per evitare che quello che scrivo sia indebolito dal sospetto di secondi fini (leggi captatio benevolontiae) ed in generale per non mettermi (troppo) in situazioni spinose).
Ieri però si è concluso il mio rapporto con la Santa Margherita e quindi posso parlare con la serenità di esprimere l’opinione di Lorenzo Biscontin, professionista di marketing che ha lavorato nel settore del vino, senza che questa possa confondersi con la posizione dell’azienda.
Siccome si tratta di un’occasione che non capita spesso (meno male), me la voglio spendere al meglio affrontando una questione che ritengo particolarmente interessante dal punto di vista del marketing per le sue implicazioni riguardo ai concetti di identità e rispetto delle persone (consumatori), pilastri della credibilità del marketing e quindi del successo di lungo periodo delle strategie.
Come si intuisce dal titolo, affronterò le problematiche legate alla gestione del marchio “Prosecco” che si sono create dal 2010 a seguito dell’istituzione della nuova DOC multiregionale e contemporaneo passaggio della precedente DOC a DOCG.
Devo chiedere scusa in anticipo sia a chi non si occupa di vino, perchè essendo un argomento in cui sono stato direttamente coinvolto capiterà che dia per assodate alcune conoscenze della questione che non sono invece così condivise da tutti, sia ai puristi del vino, perchè su alcuni aspetti enologici dovrò essere necessariamente approssimativo per evitare di dilungarmi troppo.
Sintetica descrizione del problema
Fino al 2009 il termine “Prosecco” indicava una varietà di vite e quindi vini prodotti ovunque, anche all’estero, con questa varietà di uva potevano riportare in etichetta il nome “prosecco”, sfruttando in questo modo la crescente fama e reputazione legate al Prosecco DOC Conegliano-Valdobbiadene. Va ricordato che fino al 2009 a fianco del Prosecco DOC esisteva anche il Prosecco ad Indicazione Geografica Tipica, il cui disciplinare comprendeva una zona più ampia diffusa su più regioni e rese produttive di uva per ettaro molto più elevate rispetto alla DOC. Per risolvere questa situazione di concorrenza sleale (mi spiegherò meglio in seguito), nel 2009 è stata creata la nuova DOC Prosecco, che comprende sostanzialmente Veneto e Friuli Venezia Giulia, e quindi anche la località di Prosecco in provincia di Trieste. In questo modo il termine “prosecco” non indica più una varietà di uva, ma è diventato un nome geografico, che può essere utilizzato solamente dai produttori che operano all’interno della Denominazione d’Origine. In contemporanea la vecchia DOC Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, che copre quindi le colline della parte settentrionale della provincia di Treviso, è diventata DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), il massimo livello qualitativo previsto nella legislazione vinicola italiana.
A sua volta il nome con cui si indica la varietà di uva è diventato “glera”, antico sinonimo utilizzato (credo) sul carso triestino.
Questi cambiamenti hanno creato una grande confusione sul mercato, a mio parere non del tutto giustificata dai fatti in sè, quanto dalla crisi di identità in cui sono entrati i produttori della zona storica di Conegliano e Valdobbiadene, crisi legata soprattutto alla modificata percezione di se stessi e del contesto a seguito dell’istituzione della nuova DOCG e nuova DOC.
La crisi di identità della DOCG è ancora in atto, come dimostrano la ridotta efficacia della comunicazione messa in atto ed il fatto che tra i suoi produttori si continuino periodicamente a dibattere ancora gli stessi temi discussi nel 2009, benchè il nuovo quadro legislativo li abbia di fatto, nel bene o nel male, risolti. Ecco quali sono e la mia opinione al riguardo.
L’istituzione della DOC multiregionale ed innalzamento del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene a DOCG è stata una cosa più che positiva, doverosa.
L’elemento fondante dell’istituzione di una DOC dovrebbe essere sempre la presenza di imitazioni sul mercato. Una DOC infatti ha lo scopo di proteggere il nome di un territorio, intrinsecamente un bene comune che non può essere registrato da una singola azienda, che grazie alla specificità dei prodotti che ne derivano si è guadagnato una reputazione presso il mercato che lo differenzia positivamente rispetto ad altri prodotti appartnenti alla stessa categoria. Regolamentando la produzione attraverso la DOC si garantisce il consumatore nei confronti di imitazioni e si proteggono i produttori in zona tipica dalla concorrenza sleale da produzioni realizzate fuori dall’area DOC e quindi, per definizione, di qualità diversa. La situazione in cui si trovava il prosecco IGT e soprattutto DOC prima del 2009 era esattamente questa e quindi doveva essere risolta, innanzitutto, insisto, nei confronti del consumatore.
Il Prosecco non è la Franciacorta
In questi anni non c’è stato convegno, simposio, seminario o incontro riguardante il Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, in cui non sia stato citato l’esempio della Franciacorta, che fin dall’inizio ha deciso di identificarsi solamente ed esclusivamente con il nome del territorio, a sostegno della scelta fatta nel regolamento della DOCG di dare preminenza ai termini “Conegliano” e “Valdobbiadene” rispetto a “Prosecco”. Mi è sempre sembrato un esempio fuori luogo, che aumenta la confusione invece di fare chiarezza perchè confronta situazioni inconfrontabili, rischiando di portare a scelte strategiche sbagliate.
Onore al merito agli amici franciacortini per la disciplina con cui hanno seguito la loro strategia e per i frutti che questa gli sta portando attualmente, ma quando è la nata DOC Franciacorta non disponeva comunque di altri termini che avessero un forte valore sul mercato. In altre parole si sono trovati davanti ad un foglio bianco e sono stati bravi a scriverlo nel modo migliore (non dimentichiamo però il tempo che ci è voluto). “Prosecco” invece è un termine che, sia come livello di conoscenza che di reputazione, ha un grande valore sul mercato e quindi sarebbe una grande spreco abbandonarlo, regalando tutto quel valore al Prosecco DOC.
La cosa è evidente, ed in effetti il regolamento della DOCG prevede l’utilizzo del termine “Prosecco” accompagnato dall’aggettivo “Superiore”, che una bellissima parola: qualificante e comprensibile nelle lingue parlate dai principali mercati di esportazione del vino italiano. Però l’indicazione di questi termini in etichetta è subordinata a quella di Conegliano-Valdobbiadene e quindi inferiore, anche per quanto riguarda la dimensione del carattere. Una scelta che in pratica fà sì che la parola “Prosecco” sia più evidente nelle etichette della DOC che in quelle della DOCG, creando un svantaggio competitivo e cedendo, di fatto, buona parte del valore che i produttori di Conegliano e Valdobbiadene hanno creato sul mercato.
Le rive normalmente sono sui fiumi o sui mari
Una delle innovazioni del disciplinare della DOCG Conegliano-Valdobbiadene rispetto alla situazione ante 2009 è stata l’istituzione dell’indicazione “Rive”, intendendo con questo termine il vino prodotto da uve derivanti da una specifica e limitata zona (terreni in forte pendenza) all’interno dell’area DOCG. Chi vive a sud e ad ovest dell’Adige, a nord della provinci di Trento e ad est dell’Isonzo (ma forse anche del Tagliamento) si starà chiedendo:perchè “rive”. Perchè è il termine dialettale che indica un terreno particolarmente ripido e quindi dove l’uva è di qualità particolarmente elevata.
Io non so se ci sia consciamente o inconsciamente un’influenza leghista nella scelta di questo termine, ricordo solo i clienti dalle diverse parti d’Italia che mi chiedevano se la DOCG era stata allargata, portandola fino al mare.
Criticare è facile, ma allora io cosa propongo?
Lo slogan/claim/payoff (a voi la scelta) che dà il titolo a questo post l’ho l’ho inventato io durante il primo dei seminari con le aziende organizzato ad inizio 2010 dal Consorzio per raccogliere indirizzi sulle modalità di comunicazione della nuova DOCG. Onore a me di averlo pensato, al Consorzio di aver organizzato seminari coinvolgendo le aziende (cosa non comune) ed all’agenzia di pubblicità di aver deciso di utilizzarlo (all’agenzia di pubblicità vanno anche gli eventuali oneri nel caso il claim non funzioni; è per queste assimetrie di responsabilità che prima o poi mi dedicherò all’attività di consulenza).
Secondo me racchiude il messaggio che dovrebbe essere trasferito al mercato in questa prima fase: esiste il prosecco (di pianura) ed esiste il prosecco superiore (collina). Concetto semplice, chiaro, comprensibile ed efficace. Poi di contorno posso rafforzarlo/circostanziarlo con le Rive, il Cartizze, le diverse rese per ettaro, ecc.., evitando però di dare tutto allo stesso tempo oppure ogni volta una cosa diversa, perchè così l’unico risultato è di non ottenere risultati.
Aggiungo un paio di considerazioni su certe evoluzioni a cui si sta assistendo nella scelte di prodotto delle aziende, che, secondo me, hanno il grosso difetto di essere premianti sul mercato nel breve periodo (e quindi tutti i produttori sono spinti quantomeno a considerale) e banalizzanti nel medio lungo.
Il Prosecco millesimato
Per ragioni e tradizioni che qui sarebbe troppo lungo spiegare, lo champagne (evidentemente il riferimento di tutti i vini spumanti) viene normalmente prodotto con cuvèe composte da vini di più annate. Solo nelle annate in cui l’andamento stagionale permette di avere uve eccezionalmente buone, la cuvèe viene prodotto con vino di quella singola annata, che viene quindi indicata in etichetta. Da qui che il consumatore associ al termine millesimato un prodotto di qualità superiore.
Il prosecco però, a differenza dello champagne, non è un vino che si presta all’invecchiamento. Anzi le sue caratteristiche di freschezza e fragranza si esaltano quando l’imbottigliamento è relativamente recente. Questo significa che non ha nessun senso chiedere oggi un prosecco del 2007, anche se si fosse trattato di un’ottima annata, mentre è normale (costi a parte) bere champagne millesimati invecchiati dieci anni e più.
Il millesimato nel prosecco quindi è innazitutto un controsenso tecnico, ma quello che mi manda veramente fuori di me è che i disciplinari tanto della DOC come della DOCG prevedono l’indicazione del termine “Millesimato” senza l’obbligo di indicare l’annata e quindi si trovano normalmente sul mercato prosecchi millesimati, senza sapere però di che anno.
Come ho detto all’inizio è una cosa che funziona perchè sfrutta il valore che il termine ha per il consumatore. Per me però le strategie che si basano sulla (relativa) ignoranza del consumatore sono sempre a doppio taglio e più si diffondono, più si affilano.
Il prosecco metodo classico
Qualche produttore storico della DOCG Conegliano-Valdobbiadene per differenziarsi e per sottolineare la propria qualità superiore sta proponendo sul mercato il prosecco prodotto con il metodo classico di rifermentazione in bottiglia (come lo champagne per capirsi) invece della rifermentazione in autoclave.
Premetto per correttezza che non ho ancora avuto modo di assaggiarli, ma sono molto perplesso riguardo ad operazioni di questo tipo perchè rischiano di snaturare le caratteristiche che hanno portato il prosecco al successo di cui gode oggi.
Detto in sintesi, che questo post è già troppo lungo, temo che un prosecco metodo classico perda la sua naturale freschezza e dubito che guadagni a sufficenza in corpo e struttura.
Concludo questo post ringraziando i miei più stretti collaboratori in Santa Margherita: Elena, Elisa, Lara e Alberto (che ho messo per ultimo senza rispettare il suo ordine alfabetico solo perchè so che è un gentiluomo e cede sempre il passo alle signore).
Li ringrazio per il lavoro fatto insieme, ma soprattutto per la fiducia che mi hanno dimostrato quando non si sono offesi a leggere la serie di post su “Gestione del personale ed etologia”. Y que Dios reparta suerte!
Elogio della buona pubblicità, gli esempi di Campari Orange e Durex Gel.
Dopo il feuilleton sulle ricerche di mercato, un post defatigante per me che scrivo e per chi legge.
Quando ho parlato di campagne pubblicitarie su questo blog l’ho fatto sempre citando esempi negativi di pubblicità fatta male, a mio parere ovviamente.
Oggi continuo a far soffiare il vento del cambiamento su biscomarketing parlando di due campagne in giro da un po’ che mi hanno colpito per come sono ben pensate e ben realizzate.
Perchè mi piace (in termini di AIDA ovviamente e non puramente estetici) lo spot Campari Orange ? Perchè il protagonista della storia è il prodotto/marca, inserito in una situazione di consumo, rappresentata con una soluzione tecnica nuova ed originale che sottolinea ulteriormente il posizionamento di sofisticata contemporaneità della marca. Mi sembra perfetto anche considerando la storia della comunicazione di Campari. Dopo tutta la serie degli spot iconoclastici dei primi anni duemila ed il passaggio ad una maggior “normalità” degli spot con Salma Hayek, questo spot fa avanzare la marca ulteriormente la marca in un percorso di prossimità con i propri consumatori attuali e potenziali senza perdere in glamour. Anzi in questo caso il glamour è inserito al 100% nel prodotto, mentre negli spot precedenti era un riflesso delle combinazioni storia/ambiantazione/testimonial.
Sarebbe bastato questo per farmi togliere il cappello, l’inserimento dei testi che danno la ricetta del Campari Orange lo fa diventare uno spot da applausi.
Volendo cercare proprio il pelo nell’uovo, credo che tra produzione e post produzione sia costato un botto. Però li vale tutti, Campari se lo può permettere e, comunque, sarà costato meno dei precedenti.
Per lo spot del Gel Durex solo parlare del modello AIDA – Attention – Interest – Desire – Action rischia di creare imbarazzo e questo dà già l’idea della difficoltà di fare una campagna per questo prodotto.
Una volta di più il marketing dell’azienda e l’agenzia hanno dato una dimostrazione di cosa può fare la creatività quando non è fine a se stessa, ma guidata da un preciso posizionamento e, più in generale, cultura aziendale. Dico ancora una volta ricordando lo spot del Durex ring e, se non ricordo male, quello del preservativo trovato in classe dal professore.
Inevitabilmente l’argomento trattato ha fatto sì che anche a questo spot, come ai precedenti, sia seguite un po’ di polemiche, ma riuscire ad affrontare questi argomenti in uno spot televisivo generando polemiche solamente da una parte del pubblico è un’impresa. Tra l’altro ho la convinzione che il target a cui puntava Durex abbia condiviso il “tono” dello spot.
Personalmente poi mi ha colpito l’uso del termine “multisensoriale” utilizzato per descrivere l’allargamento di gamma perchè nel 2007 con Keglevich abbiamo fatto un tour nelle discoteche basato sul “Responsible fun: when you love, when you drink”. Chissà che l’idea del multisensoriale non gli sia stata ispirata dalle categorie sensoriali dei gusti Keglevich? Bisogna che lo chieda a Corrado, direttore marketing di Durex e vecchio compagno di Università e di appartamento (i percorsi a cui può portare una laurea in Scienze delle Produzioni Animali sono imprevedibili).
Le ricerche bisogna saperle scrivere 5
Lo so che sono un po’ in ritardo con questo post, ma, come mi ha detto qualcuno tempo fa, è un periodo di cambiamenti e di conseguenza un po’ complesso.
Stavolta prometto che concludo l’argomento ricerche di mercato.
I punti che mi sono rimasti nella penna (tastiera) l’altro giorno sono sostanzialmente due.
I database generati dalle ricerche contengono molte più informazioni delle semplici dati, basta saperli organizzare.
Tempo fa ho commissionato una (tipica) analisi nuovi-persi-stabili basata sui dati scanner delle carte fedeltà riferiti ad uno specifico prodotto (singolo codice EAN). Mi sono arrivati tutti gli indicatori demografici ed i panieri dei relativi gruppi. Cose sicuramente utili, alle quali però io ho aggiunto un’informazione che ritengo particolarmente interessante per la definizione delle strategie: le sovrapposizioni e le NON sovrapposzioni dei panieri di acquisto dei diversi gruppi. In altre parole, partendo dal database grezzo, ho evidenziato quali prodotti sono esclusivi di ogni singolo gruppo, quali sono comuni a tutti e tre, quali sono comuni solo a nuovi+persi, quali a persi+stabili e quali a nuovi+stabili. Ho aggiunto anche il peso sul valore totale del paniere acquistato dei prodotti comuni e di quelli esclusivi,l nonchè il prezzo medio unitario del paniere. Il tutto con le relative variazioni rispetto all’anno precedente.
Tutto questo per dire che nei dati di una ricerca ci sono risposte a più domande di quelle di partenza, risposte che nascono dall’associazione tra risposte a diverse domande, secondo ipotesi di comportamento dell’universo analizzato che siano rilevanti per la definizione dell strategie. Con questo intendo che ipotizzato un certo processo comportamentale, verificare o meno la significatività dell’associazione tra risposte diverse permette di ottenere informazioni importanti, senza che ci sia la necessità di chiederle esplicitamente, e così di allungare il questionario inutilmente.
Anche in questo caso un esempio chiarisce le cose: confrontando la frequenza di acquisto di una categoria di prodotto con il prezzo medio pagato (o con lacquisto o meno di una certa marca) posso individuare eventualio comportamenti diversi delle diverse cluster (gruppi) definiti dalla frequenza di acquisto rispetto alla distribuzione media del campione. Questo senza necessità di domandare il prezzo medio ad ogni singola cluster di frequenza d’acquisto. Sto parlando dei classici indici di concentrazione che vanno a dinviduare se la combinazione di due variabili è diversa dalla distribuzione normale in modo statisticamente significativo. Anche in questo caso non si tratta di fisica nucleare ba di un normalissimo test del Chi quadrato per misurare la distribuzione di frequenza delle risposte del campione incrociando due variabili (domande).
La raccomandazione quindi è: prima di ampliare i vostro progetto di ricerca o, peggio ancora, allungare e complicare il questionario, assicuratevi di aver strizzato tutte le informazioni disponibili nel database sulla base delle vostre ipotesi strategice. Anche perchè le ipotesi strategiche sono quelle sulla base delle quali avreste dovuto già disegnare il questionario e quindi sono quelle che organizzano i dati in informazioni. Se vi mancano le ipotesi strategiche, aumentare la quantità di dati disponibili vi porterà solamente ad una maggior confusione.
La scienza statistica dispone di tutto un ventaglio di strumenti di analisi:usateli!
Avendo passato un po’ di anni in università ad occuparmi di analisi statistica, rimango sempre stupito della distanza tra la raffinatezza e capacità interpretativo/informativa degli strumenti disponibili (e mi limito a quelli consolidati, tralasciando la frontiera della ricerca, che oramai non conosco più) e la pochezza di quelli effettivamente utilizzati nelle ricerche di marketing realizzate da e per conto delle aziende. Succede ancora che la media, l’indicatore dei poveretti, non sia uno dei parametri di partenza per individuare gli scostamenti (le veri informazioni strategiche), ma l’indicatore di arrivo.
Non voglio fare qui un trattato di statistica multivariata, anche perchè è pieno di persone molto più qualificate di me al riguardo, però almeno ricordare che ci sono tecniche quantitative che permettono di circostanziare/predire il comportamento dei consumatori, quello sì. E’ vero che per essere applicate queste analisi richiedono di partire da un datbase con determinate cratteristiche, e quindi da questionari strutturati in un certo modo, ma non è che questo sia antitetico rispetto all’amalisi monovariata e, soprattutto, i vantaggi che ne derivano compensano ampiamente il, pivvolo, sfrozo.
Io personalmente sono sempre stato un fan dell’analisi fattoriale, perchè i fattori si generano in ordine decrescente di varianza spiegata e quindi permettono di costruire matrici bidimensionali “pesate”. Altra tecnica che mi è sempre piaciuta, ma che ho utilizzato solamente un paio di volte, è la conjoint analysis per il potenziale informativo che offre riguardo alle scelte del consumatore.
Qui mi fermo, perchè lo scopo di un post su questi temi non può essere evidentemente essere quello di approfondire/esaurire la materia, ma solamente di dare degli stimoli per spingere chi realizza ed utilizza le ricerche di mercato di andare oltre il solito. Se le cose appaiono troppo complesse non spaventatevi, ma sforzatevi invece di andarci dentro per comprenderle. Poi non è detto che sia possibile semplificarle, ma le vostre strategie saranno comunque migliori di quelle basate su analisi semplicistiche.
Concludo con una frase che ho trovato recentemente in un articolo su Marketing Management del dicembre 2008: Marketers must learn to lead with imagination driven by consumer insight and not rely on marketing research for predictions.
Cominciando oggi si è indietro solo di due anni e mezzo (ma mi sto mettendo in pari). E qui chiudo per davvero la serie dei post sulle ricerche di marketing.
Le ricerche bisogna saperle scrivere 4
Come annunciato concludo questa serie di post sulle ricerche di marketing con alcune riflessioni su come queste vanno lette, o meglio analizzate.
Se avete dei dubbi sui risultati di una ricerca, approfondite.
Con questo non voglio dire di non credere alle ricerche solo perchè i risultati che forniscono sembrano andare contro alle nostre aspettative, però l’esperienza e la conoscenza che viene dalla frequentazione continua del settore in cui si opera devono essere dei parametri per far suonare campanelli d’allarme di fronte ad indicazioni che appaiono anomale. In questi casi è doveroso approfondire le modalità di esecuzione della ricerca e di analisi dei dati, per confermare che i risultati siano effettivamente affidabili. Ricordiamoci che quasi sempre la consocenza delle dinamiche del settore che ha l’istituto di ricerca è sporadica rispetto alla nostra; se da una parte questo porta il vantaggio di una visione libera da pregiudizi, dall’altro noi commitenti abbiamo il compito di rilevare eventuali cantonate, sempre in aggiuato. Ancora una volta sottolineo che non parlo di teoria astratta, bensì di (a volte dura) realtà. Qualche anno fa sono stato coinvolto in una ricerca pan-eropea relativamente ai livelli di conoscenza , acquisto e fedeltà di una marca che distribuivamo in Italia. L’istituto che seguiva tutto il progetto quindi era straniero e si era appoggiato ad una istituto italiano solamente per la realizzaizone delle interviste (ora non ricordo se telefoniche oppure on-line, ma poco importa). I risultati per l’Italia mostravano un’elevata conoscenza (awareness) ed una positiva percezione della marca con livelli invece molto bassi di acquisto e praticamente inesistenti di fedeltà. Il proprietario della marca quindi ci stimolava ad individuare delle strategie che riuscissero a convertire questo elevato numero di potenziali consumatori in consumatori effettivi. Questi dati però contrastavano sia con la percezione che avevamo in azienda del mercato, sia con i risultati di una ricerca che avevamo svolto noi circa un anno prima. Analizzando il database ottenuto dalle interviste (che, dopo qualche insistenza, sono riuscito ad avere) ho notato che nell’analisi delle risposte la lista delle marche a volte era in ordine alfabetico mentre altre volte era in ordine decrescente di conoscenza. Analizzando le due liste per me era chiaro che c’era stata un’inversione e che ai dati di conoscenza in ordine descrescente fosse poi stata associata la lista delle marche in ordine alfabetico, in considerazione anche del fatto che il risultato di conoscenza che sembrava incredibile per la nostra marca, si adattava invece benissimo alla marca a cui avrebbe corrisposto nel caso dell’inversione delle liste durante le analisi. Mi ci sono volute parecchie telefonate ed un incontro di persona con il Direttore Marketing internazionale della marca in questione ed i responsabili del progetto di ricerca per convincerli a fare questa verifica. Alla fine si è scoperto che avevo ragione io, ovviamente l’Istituto non sapeva spiegarsi come aveva potuto accadere, invece, come dicono gli americani, shit happens e non c’è nessun problema. Solamente quando si sente la puzza sarebbe meglio guardare sotto la suola invece di far di niente per non voler vedere che le nostre belle scarpe si sono sporcate. Approfitto per sottolineare come informazioni informazioni sbagliate portino a decisioni dannose; nel nostro caso l’impostazione di una strategia opposta a quella necessaria (spinta all’acquisto vs. costruzione di awarness).
L’errore campionario è una cosa seria
Detto in sintesi e con tutte le inesattezze di un non-statistico come me, l’errore campionario in una ricerca di mercato è la percentuale di probabilità che un determinato numero sia effettivamente quello con un determinato intervallo di confidenza (solitamente il 95%). Detto in termini più chiari e più pratici una ricerca svolta su un campione di 1.000 persone ha un errore campionario del +/- 3,16%. Questo significa che in un questionario con domande a risposta multipla, se una domanda ha ricevuto il 15% di risposte, questo 15% è in realtà compreso tra 11,84% e 18,16%.
Si tratta di un’informazione cruciale nel leggere i risultati di una ricerca di mercato, perchè permette di sapere quali numeri sono effettivamente diversi (ad essere più precisi diversi in misura statisticamente significativa) e quali invece appaiono diversi a causa dell’errore campionario, mentre sono in realtà, statisticamente parlando, lo stesso numero. Sempre andando sul concreto e mantenendo l’esempio precedente, 15% ed 11% sono, statisticamente parlando, lo stesso numero in quanto i loro intervalli si sovrappongono: 11%+3,16%= 14,16%, 15%-3,16%= 11,84%.
Attenzione 1: spesso nel corso di un’intervista alcune domande vengono sottoposte solamente ad una parte selezionata del campione iniziale, ad esempio solo ai consumatori che hanno visto la pubblicità della marca. In questo caso la base campionaria si riduce e l’errore aumenta in modo esponenziale (per la precisione al quadrato).
Attenzione 2: nel corso degli anni ho sentito Istituti e ricercatori, anche autorevoli, parlare dell’importanza di cogliere i segnali deboli dati da piccole differenze anche su campioni limitati. Non discuto dell’utilità di cogliere i segnali deboli, non sono però d’accordo all’interpretazione dei dati delle ricerche quantitative come se le leggi matematiche dell’inferenza statistica non esistessero.
Attenzione 3: tutte quello che ho detto sopra NON vale per ricerche che vanno a misurare parametri metrici, pesi e misure, a meno che questi non vengano ricondotti ad intervalli chiusi in domande a risposta multipla. Si tratta comunque di tipologie di indagine estremamente rare nell’ambito delle ricerche di mercato (per chi fosse comunque interessato, il link di wikipedia all’inizio del paragrafo può essere un punto di partenza per approfondimenti).
Concludo il paragrafo svelando la (semplice) formula per calcolare l’errore campionario di una ricerca: E= 1/√n*100, dove n è la numerosità del campione. Tornando all’esempio concreto di cui sopra: E= radice quadrata di 1/1.000.
Qui mi fermo, anche se ci sono ancora un paio di aspetti che volevo affrontare, perchè mi sembra che il post sia già molto denso.
Quindi mi smentisco una volta di più e rimando la conclusione alla quinta e, davvero, ultima puntata.
Le ricerche bisogna saperle scrivere 3
Visto che il titolo di questa serie di posts è “Le ricerche bisogna saperle scrivere”, ho pensato che forse sarebbe stato opportuno spendere due parole su come scrivere le ricerche di marketing. Niente di particolarmente approfondito su un tema dalla bibliografia sterminata; semplicemente alcune dritte che nascono dall’esperienza di ricercatore prima e committente di ricerche poi, che possono aiutare ad evitare gli errori più marchiani. Esprimerò i concetti in modo volutamente manicheo, perché poi tanto ci pensa la pressione dell’operatività quotidiana a portarci nelle zone grige delle eccezioni alle regole e dei compromessi.
Le metodiche qualitative servono per aprire le domande, quelle quantitative per chiudere le risposte.
Alcuni anni fa seguii 4 focus groups negli USA che avevano come oggetto principale il cambio di packaging di un prodotto già esistente. Alla fine dell’ultimo focus group il responsabile del progetto mi disse sconsolato che era più confuso di prima riguardo all’implementazione del nuovo pack, per la ridotta convergenza riscontrata su questo argomento nelle discussioni dei gruppi. In quel momento ho capito che veramente speravano di ottenere una risposta definitiva dai consumatori attraverso i focus groups, ottenendo il doppio risultato di esplorare le motivazioni e gli atteggiamenti nei confronti della categoria e la validazione della nuova ipotesi, risparmiando quindi sui costi di ricerca. Potete stare certi che queste giocate non riescono neanche ai più bravi tra i migliori. Tra l’altro che validazione ci può essere nelle risposte di 32 persone. Io sono sempre stato d’accordo con Feargall Queen che diceva che i focus group sono quello strumento che ti permette di ascoltare l’opinione/l’idea/il suggerimento di quell’unico partecipante che ha ragione. Che poi riconoscerne la ragione sia conseguenza di una validazione tramite una ricerca quantitativa o di una valutazione del management è tutto un altro discorso.
Parallelamente pensare di scoprire opinioni/motivazioni/atteggiamenti inattesi attraverso ricerche quantitative è altrettanto illusorio.
I questionari, quanto più brevi, meglio.
Il mio professore di Research in Consumer Studies in Canada esortava a costruire questionari che comprendessero tutto il need to know (necessario) e niente nice to know (utile). Che sia una disciplina difficile da seguire lo esprimono già le parole, perché tutti vorremmo raccogliere le informazioni utili oltre a quelle necessarie. I vantaggi di limitarsi solo al necessario sono però molti e superano quelli che possono provenire dall’utile.
1) Aiuta a definire con maggior precisione gli obiettivi della ricerca (vedi post precedente).
2) Aiuta a mantenere breve e focalizzato il questionario che risulterà quindi più facile per l’intervistato.
3) La chiarezza degli obiettivi dell’indagine, unita alla chiarezza delle risposte da parte degli intervistati, porta ad una maggior chiarezza dei risultati.
4) Sottoporre un questionario a qualcuno significa comunque disturbarlo; questionari brevi e chiari riducono il disturbo e quindi rendono le persone più disponibili a partecipare ad altre ricerche in futuro e meno critiche al sistema delle ricerche di marketing in generale.
Il rischio principale dei questionari lunghi e faticosi (serie infinite di scale di valutazione/accordo-disaccordo delle affermazioni più disparate) è l’inaffidabilità delle risposte. Una volta che una persona è coinvolta in un questionario, sarà improbabile che lo tronchi a metà (soprattutto se l’intervistatore cercherà di convincerlo che manca poco per poter completare la rilevazione. A questo punto le persone cominciano a rispondere a caso, sia inconsciamente per la perdita di attenzione che scientemente per “vendicarsi” del disturbo. Il questionario sarà sì completo, ma dannoso per la distorsione occulta che introduce nella rilevazione complessiva.
Può sembrare che queste raccomandazioni fossero valide più in passato, quando le ricerche si basavano su interviste personali o telefoniche, che non per le ricerche eseguite on-line su liste di persone che hanno dato la loro disponibilità a partecipare ad indagini di mercato, che predominano oggi.
Pur convivendo il fatto che rispondere ai questionari on-line sia intrinsecamente più facile (le persone scelgono il momento in cui rispondono, è possibile inserire immagini, ecc…), io resto convinto che sforzarsi a costruire un questionario essenziale nei contenuti e logico nella struttura dia maggiori garanzie di ottenere risposte a quello che realmente si voleva chiedere.
L’interpretazione univoca delle domande da parte degli intervistati non va dta per scontata, ma va conquistata.
Quello che per noi sembra automatico ed ovvio, per l’intervistato non lo è. Detta così sembra una banalità, ma recentemente ho assistito alla presentazione di una ricerca sulla forze delle marche di diversi settori ed in quello alimentare alla domanda “Quali marche negli ultimi tempi hanno particolarmente attirato il suo interesse” al primo posto appariva Parmalat. Scusate lo scetticismo, ma dubito che questo risultato fosse indipendente dalla presenza continua sui media di notizie riguardanti il tentativo di acquisizione di Lactalis. Non ho invece alcun dubbio che l’interesse manifestato a seguito di questa domanda non fornisce alcuna indicazione sulla valutazione positivi, negativa o neutra che gli intervistati danno alle marche citate.
Questo mi sembra un eccellente esempio di indeterminatezza dovuta alla cattiva scrittura del questionario, che permette quindi di leggerne i risultati come si vuole.
Per evitare situazioni simili è indispensabile scrivere le domande in modo che la loro interpretazione da parte degli intervistati sia univoca in modo che quello che capiscono sia effettivamente quello che volevamo chiedere e che le possibili risposte siano altrettanto chiare, in modo che noi altrettanto univocamente capiamo quello che loro volevano effettivamente rispondere.
Il classico consiglio che si dà in questi casi è di mettersi nei panni dell’intervistato, ma quando si sta portando avanti un progetto di ricerca ci si immersi fino al collo e tirarsene fuori diventa difficile e faticoso. Io preferisco chiedere a qualche collega di altre funzioni (il più possibile distanti dal marketing) di rispondere alla bozza del questionario. E’ un sistema molto più veloce ed efficace per individuare i punti controversi.
Concludo il post ricordando quali sono le informazioni essenziali che dovrebbe fornire una ricerca di marketing:
- chi, cosa, dove, come quando e perché compra.
- chi, cosa, dove, come quando e perché consuma.
Non concludo invece la serie, perchè mi riservo un ultimo post dove, ad apparente smentita di quanto ho scritto finora e della mia naturale razionalità mercuriale, affronterò il tema di come leggere le ricerche di marketing. Così tanto per smentire una volta di più gli oroscopi e perchè è un periodo di cambiamenti e quindi … all my life I have been good, but now I am thinking what the hell!
Le ricerche bisogna saperle scrivere 2
Con mezza giornata di ritardo, mantengo la promessa di proseguire il post dell’altro ieri (il link neanche lo metto, andate sul sito e lo trovate sotto a questo).
La voglia di affrontare questo argomento mi è venuta perchè fin dalla prima azienda in cui ho lavorato, più di una volta mi è capitato di sentire la frase “le ricerche bisogna saperle leggere”. Addirittura mi è capitato di veder scegliere un’istituto sulla base della loro capacità di interpretare (non analizzare, che è ben altra cosa) i dati. E’un concetto che contesto con forza, e questo immagino si fosse capito, perchè inserisce una componente di soggettività che svuota di significato il disegno della ricerca ed i risultati ottenuti, rischiando di raggiungere l’unico scopo di supportare le proprie aspettative/convizioni pregresse su una base (pseudo)scientifica. Questo non significa che l’opinione/visione/esperienza di esperti di un settore o di una materia, piuttosto che del management dell’azienda, non abbia validità; semplicemente che con se questa sarà la base delle decisioni è meglio risparmiare il tempo ed i soldi necessari per fare una ricerca.
Purtroppo mi anche capitato di vedere istituti di ricerca che vendevano più la loro esperienza e consocenza di una detrminata tematica piuttosto che le proprie competenze nello sviluppare un progetto di ricerca solido rispetto agli obiettivi di conoscenza del cliente. Raccomando quindi attenzione nel valutare l’istituto con cui lavorare; soprattutto nel caso in cui le vostre competenze specifiche di ricerche di marcato fossero limitate (tecniche di campionato, struttura del questionario e verbalizzazione delle domande, strumenti di analisi statistica, ecc..) il mio consiglio è di analizzare la solidità e coerenza intrinseca tra le modalità di ricerca proposte ed i vostri obiettivi informativi. Per totale chiarezza sottolineo la differenza tra dato ed informazione, dove la questa deriva dal significato che assumono i primi, organizzati secondo le logiche e necessità di conoscenza con cui è stata sviluppata la ricerca. E qui ricordo una volta di più che queste logiche sono in gran parte contenute nell’importazione della ricerca a priori, più che nell’analisi a posteriori.
In altre parole, per ridurre il rischio di prendere la decisione sbagliata non servono dati, ma servono informazioni. attenzione quindi, soprattutto nella aziende medio piccole, ai progetti di ricerca standard perchè mi è capitato di vedere anche istituti di ricerca che proponevano il loro specifico modello di analisi (di cui avevano persino il copyright). Ripeto una volta di più che il marketing è una disciplina analitica, non deterministica.
Tornando al nocciolo della questione, le ricerche bisogna saperle scrivere, perchè quanto più saranno scritte bene e quanto più i risultati saranno chiari, univoci e solidi, indipentemente di chi li andrà a leggere (con l’ovvio presupposto che chi li legge sappia come è stata scritta). Questo significa che i comportamenti e/o le opinioni identificate dalla ricerca sono effettivamente quelli che riscontrano sul mercato e non sono il frutto di distorsioni implicite nella realizzazione della ricerca o, peggio ancora, nella sua “interpretazione”. Le situazioni in cui la ricerca indica situazioni di indeterminatezza sono quelle in cui la garanzia di solidità dell’indigine è particolamente importante, perchè sono quelle in cui si è più portati ad inclinarsi in una direzione secondo le proprie aspettative/convinzioni oppure a mettere in dubbio la validità di tutta l’indagine sul presupposto della sua incapacità di individuare i fenomeni con precisione. Solo la serenità sulla convinzione della solidità dell’indagine permette di accettare che su quella questione il mercato non ha ancora sviluppato una posizione/opinione, informazione oltremodo preziosa nello sviluppo delle strategie.
Mi rendo conto che l’argomento è più corposo e complesso di quello che mi aspettavo, oltrettutto scrivere al mattino è per me un’esperienza nuva che mi sembra mi porta ad essere più arzigogolato con poco vantaggio per la chiarezza (sarà perchè sono troppo riposato). Per adesso quindi mi fermo qui, annunciando già una prossima puntata (o anche due).
Le ricerche bisogna saperle scrivere 1
Premessa n.A: confessa la mia preoccupazione nello scrivere questo post perchè vedo elevatissimo il rischio di spiegarmi male/essere frainteso. Anche perchè tra le discipline legate al marketing, quella della ricerca di marketing è probabilmente la più svilita e la meno conosciuta già dagli operatori del marketing, figuriamoci dai loro interlocutori. Questo implica che l’interpretazione dei risultati di una ricerca sulla base di qeulla che è la propria esperienza/convinzione personale è all’ordine del giorno in aziende di tutti i livelli (ricordo una decina di anni fa l’amministratore delegato della filiale italiana di uno dei principali produttori di automobili mondiali che si convinse della bontà di pianificare la campagna pubblicitaria durante le partite di calcio trasmesse da Sky solo il giorno che il suo autista gli fece i complimenti per la scelta).
Premessa n.B: il ridursi della capacità delle ricerche di marketing di fornire indicazioni rilevanti a fronte della crescente complessità dei comportamenti di acquisto delle persone è una delle principali cause della difficoltà del marketing a definire delle strategie credibili e di successo, che a sua volta causa la marginalizzazione della funzione marketing all’interno della maggior parte delle aziende attuali.
Premessa n.C: il valore massimo di una ricerca di marketing è pari al costo della decisione sbagliata. L’affermazione può sembrare totalmente astratta o perfino tautologica, ma, basta pensarci con attenzione, è la più chiara, precisa e completa che si possa formulare. E’ importante far notare la sua implicazione diretta: se non ci sono opzioni tra cui scegliere, fare una ricerca di marketing è inutile. Anche questa può sembrare un’affermazione astratta, ma chi ha lavorato in azienda, soprattutto in realtà medio piccole, magari padronali, come sono la maggior parte di quelle italiane, sa quanto spesso le decisioni che si prendono siano conseguenza di convinzioni della direzione basate su esperienza, situazioni interne all’pazienda o reazioni ai cambiamenti dello scenario competitivo. Ci sono comunque anche le situazioni fisiologiche: a me è successo di gestire modifiche di prodotto (packaging e/o ricette) che implicavano risparmi tali per cui la perdita di volumi adottando la nuova modifica che andava sotto al breack-even rispetto alla situazione precedente era talmente elevata da poterla tranquillamente considerare impossibile e quindi da rendere inutile la ricerca.
Premessa n. D: ogni volta che si fa una ricerca inutile, o che diventa tale perchè non viene valorizzata per l’orientamento che porta allo sviluppo e realilzzazione di strategie e tattiche, si mina la credibilità delle ricerche tout-court. Continuo a rimenere stupito della resistenza che hanno le aziende a spendere 5.000 per una ricerca post test che permetta di capire quali sono stati gli effetti di una campagna pubblicitaria (tanto per dirne una) da 500.000 euro.
Premessa n.E (e qui il rischio di fraintedimento schizza alle stelle): il dato nudo e crudo non esiste. un dato è sempre figlio della sua modalità di rilevazione, che a sua volta è (dovrebbe essere) determinato dagli obiettivi della ricerca. Attenzione: anche se la ricerca non ha un obiettivo specifico (premessa comunque di una pessima ricerca), il dato comunque è stato raccolto/creato in un determinato modo e questo modo lo caratterizza in un senso piuttosto che un’altro. Esempio banalissimo indagine telefonica rispetto ad indagine via web (se volete divertirvi inserite pure la variabile telefono fisso/mobile). Per cercare di fare chiarezza è importante sottolineare che questa dipendenza del dato, e quindi dell’informazione che se ne può ottenere, dalla metodologia di ricerca non riguarda solo le ricerche di marketing, bensì la ricerca tout-court. Quando facevo lo scienzato economista agrario mi colpiva sempre la differente struttura degli articoli scientifici italiani e quelli del mondo anglosassone. I nostri tipicamente prevedevano circa 3-4 pagine di introduzione, altre 4-5 di analisi dei dati e metodologia, 5-6 di analisi dei risultati ed altrettante (almeno) di conclusioni. Quelli anglosassoni erano fatti di (massimo) 2 pagine di introduzione 6-7 di analisi dei dati e metodologia, 2-3 di analisi dei risultati ed 1 di conclusioni. Questo perchè il lavoro di ricerca consisteva (consiste) nell’ipotesi che stanno alla base della scelta dei dati e della metodologia utilizzata per analizzarli (che non può essere arbitraria, ma deve essere coerente con gli obiettivi della ricerca). Dopodichè i risultati di conferma o meno della tesi di partenza o di evidenziazione di qualcosa di assolutamente diverso ed inaspettato, sono una conseguenza diretta, e non interpretabile, della fase precedente e quindi anche le conclusioni sono assolutamente lineari, quasi automatiche. In altre parole la discussione scientifica sta poco nei risultati e per niente nelle conclusioni, bensì nella definizione dell’analisi. In altre parole ancora la verità non è mai pura e raramente è semplice.
Con quest’ultima premessa siamo arrivati al nocciolo della questione, però è già tardi e continuerò domani (prometto).
Inversioni di marketing: Keglevich + Limoncè
Quando ho visto la promozione della foto qui sotto mi è venuto in mente un, oramai, vecchio libro di Domenico Barili, ai tempi Direttore Marketing di Parmalat.
 .
.
Questo sia per il titolo, “Inversioni di marketing” appunto, che pensando al percorso fatto dall’azienda di Collecchio. Va detto per onor di cronaca che, a quanto ne so, Barili non è mai stato coinvolto in alcun modo nelle vicende del crack Parmalat.
Per correttezza aggiungo anche che ho ovviamente un occhio particolarmente attento per marche come Keglevich (che ho gestito per 7 anni prima da Group Brand Manager e poi da Direttore Marketing) e Limoncè (che ho gestito per tre anni e mezzo da Dir. Mktg) e credo si possa intuire la mia limitata stima per l’attuale gestione di quella che era la Stock di Trieste.
Tutto ciò premesso, la domanda è semplice: cosa c’entra la Keglevich con Limoncè? A voler scendere dal livello di marca a quello di prodotto: cosa c’entra la Keglevich Vodka Classica con il nuovo Amaro Limoncè?
Tanti anni fa un mio chairman mi disse che le brand-extension funzionano solamente se si rivolgono allo stesso target occupando un diverso momento/modalità di consumo oppure se si rivolgono ad un target diverso e nuovo rispetto all’esistente. In questi casi sostanzialmente si annullanno i rischi di cannibalizzazione e le prospettive di aumento del volume d’affari possono compensare il rischio, sempre difficile da valutare, di diluzione dell’immagine della marca.
A prima vista qui potremmo ricadere nel caso del diverso momento di consumo, visto che il target per l’Amaro Limoncè si assume per definizione il medesimo Della Keglevich Classica utilizzando lo strumento promozionale del gift on pack.
Il punto però è che qui non si tratta di una brand extension, ma dell’abbinamento tra due brand diversi, leader di due categorie affini (liquori da dopopasto e distillati da cocktail), quindi con un’immagine ed una personalità forte e chiara.
Allora che interesse può avere il consumatore di Keglevich Classica, che avrà tra i 20 ed i 30 anni (massimo) e la utilizza per un consumo miscelato a provare un amaro, categoria di prodotto tradizionale, che si consuma liscio, a marchio Limoncè? Dell’ascesa e declino del marchio Limoncè, se volete parliamo un’altra volta, altrimenti questo post rischia di diventare troppo lungo ed antipatico.
Secondo me l’interesse è minimo, mentre l’indebolimento per l’immagine di Keglevich è elevato.
Di base poi io non credo per niente al concetto dell’Amaro Limoncè perchè ho visto le ricerche di dieci anni fa che dimostravano come Limoncè fosse un marchio estremamente forte, evocativo, ma stretto che non ammetteva estensioni al di fuori del limone (nomen omen) ed ho visto l’esperienza, negativa, del Limoncè Mint.
Qualcuno potrà dirmi che in dieci anni sono cambiate tante cose (ovvio), io però ricordo sempre quello che mi disse un giorno un filibustriere titolare di una media agenzia pubblicitaria del nord-est: le ricerche bisogna saperle leggere. B U G I A: LE RICERCHE BISOGNA SAPERLE SCRIVERE. Ne parliamo sul prossimo post.
I dettagli NON fanno la differenza
“The devil is in the details”, trovare questa frase come titolo di un articolo della rivista dell’AMA “Marketing Management” nel 2007 fu uno di quei momenti di soddisfazione professionale perchè da alcuni mesi il motto del mio ufficio marketing in Stock era “Sono i dettagli che fanno la differenza”. E per quanto uno sia convinto che le sue idee siano buone, trovare una conferma di quel livello è sempre di conforto (oltre a rendere sempre più labile il confine tra orgoglio e presunzione).
Il concetto era sorto dall’osservazione della pratica del business ed era diventato una sorta di linea guida nella realizzazione dell nostre strategie, quasi una precondizione del successo, che sembrava trovare continue conferme. Quella che mi sembrò più evidente fu quando, durante gli incontri con i potenziali acquirenti della Stock, un Direttore Generale di un’importante azienda concorrente mi disse “Biscontin io proprio non capisco, adesso che vedo le vostre startegie dal di dentro mi convinco sempre di più che noi facciamo circa le stesse cose, eppure voi avete una quota di mercato superiore al 50% che continua a crescere, mentre noi siamo stabili come quota e perdiamo in vendite assolute”. al che io ho risposto che tutta la differenza stava in quel “circa” e quel circa era fatto di dettagli.
Oggi continuo a pensare che la differenza fosse tutta in quel circa, ma non sono così sicuro che quel circa fosse fatto di dettagli, oppure bisogna capirsi su cosa si intende per dettagli.
Il fatto è che il concetto di cura del dettagli è gratificante per chi segue un progetto, lo fa sentire un professionista migliore, superiore alla massa che si accontenta di fare le cose come può o come vengono. In una parola è un concetto a cui è bello credere (un po’ come ad “amor ch’a nullo amato amar perdona” per fare un paragone che conoscono tutti).
Il problema però è che cercare di seguire (seguirli davvero tutti è impossibile) tutti i dettagli è estremamente dispendioso in termini di tempo e di soldi e quindi implica un grande rischio di inefficenza ed inefficacia causato dalla perdita di focalizzazione sulle cose veramente rilevanti per il successo del progetto.
Non sono considerazioni che faccio alla leggera, “Sono i dettagli che fanno la differenza” è il monito che campeggia ancora sulla pagina generale del mio profilo Netvibes, però incomincio ad avere dei forti dubbi.
Sarà perchè ultimamente ho ragionato un po’ di oceani rossi ed oceani blu, ma credo che la differenza tra due o più proposte in apparenza simili la faccia l’originalità e la rilevanza del concetto sottostante. Poi è evidente che se questo concetto è supportato coerentemente e con forza da tutti gli elementi della sua implementazione è meglio, però ottimi dettagli non daranno il successo ad un concetto debole e, viceversa, pessimi dettagli non potranno affossare un concetto forte.
Faccio un esempio pratico: neò 2007 in Stock abbiamo cambiato radicalmente il packaging della vodka Keglevich alla frutta, passanto dalla bottiglia smerigliata con etichetta ed una bottiglia trasparente interamente coperta da uno sleever (film plastico che avvolge tutta la bottiglia). Questo ci ha permesso di lavorare con la grafica su tutta la superfice della bottiglia e sviluppare un’immagine del prodotto maggiormente in linea con il concetto di posizionamento “Your Fun”. Per una serie di ragioni tecniche nei primi mesi (almeno 6) lo sleever era evidentemente storto in circa il 10% delle bottiglie, con il risultato che le bottiglie a scaffale apparivano un po’ diverse tra loro. Eppure, malgrado questo dettaglio scadente, la bontà della grafica era tale che la forza del concetto passava ugualmente e quindi la quota di mercato continuò a crescere ben oltre il 50%.
Forse la prioritizzazione tra elementi di differenziazione sostanziali e di contorno è uno di quegli elementi del “barebone marketing” che ho annunciato qualche post fa. Fatto sta che oggi mi sto convincendo che sia sempre più cruciale non fossilizzarsi sui dettagli (inutili) ed investire più tempo nell’identificare quali sono gli elementi sostanziali, anche solo approccio concettuale e che quindi non sempre si manifestano in modo eclatante, ma che fanno realmente la differenza.
Attenzione che non si tratta di elementi fissi, perchè il plus di oggi è destinato a diventare il must di domani.
Non so se centra o se addirittura smentisce tutto quello che ho detto fino a qua, ma ieri ho visto al supermercato le nuove confezioni di caffè illy con la pennellata d’artista di diverso colore che identifica le varie miscele. Posto la foto senza commenti, prima che si dica che ce l’ho con loro.

illy, Lavazza ed il riciclo delle capsule
Leggo sul numero di aprile della rivista della COOP nella rubrica “Italiani brava gente” a firma Cirri-Solibello (conduttori di “Caterpillar” su radio2, mio appuntamento fisso se sono in macchina dalle 18:00 alle 19:30) l’esperienza di riciclo del comune di Capannori, provincia di Lucca.
A Capannori hanno un progetto chiamato “Rifiuti Zero” per arrivare entro il 2020 e non produrre più alcun rifiuto. Oggi sono all’81% di differenziata ed hanno attivato diverse azioni per evitare la produzione di rifiuti a monte (prima del riciclo c’è il minor uso come insegna la famosa regola delle 3 R dell’ecosostenibilità: nell’ordine RIDUCI, RIUSA, RICICLA). Secondo questo approccio sono andati ad analizzare cosa c’è in quel 19% di rifiuti non differenziabili ed hanno scoperto che un volume rilevante è dovuto alle capsule per l’espresso fatto con le macchinette da uso domestico/ufficio. A Capannori ogni anno ne utilizzano 750.000 del 1.000.000.000 che se ne consumano in Italia.
Queste capsule sono indifferenziabili perchè non possono essere riciclate con la plastica a causa della polvere di caffè che contengono e, meno che meno, possono essere riciclate come materiale organico a causa della plastica di cui sono fatte.
Allora l’assessore all’Ambiente di Capannori ha scritto alla Lavazza per stimolare lo sviluppo industriale delle alternative già esistenti, tipo capsule biodegradabili, riciclabili o cialde in carta compostabili. Para che la Lavazza abbia colto lo spunto e ci stiano lavorando.
Fin qui la cronaca, ma perchè ne sto parlando? Perchè di questo articolo mi hanno colpito alcune cose.
La prima è che poco meno di un anno fa affrontavo su questo blog la medesima questione, analizzando la posizione di Illy. Scoprire di essere in sintonia (e magari un po’ in anticipo) con quello che succede nel mondo è sempre una bella rissicurazione.
Soprattutto però mi ha colpito il fatto che i signori di Capannori si siano rivolti a Lavazza, quando proprio illy è stato tra i pionieri nell’ideazione delle cialde.
Lavazza è storicamente l’azienda leader in Italia nel mercato del caffè in termini di quota di mercato, ma illy aveva una leadership che io ritengo più importante: la leadership delle idee.
In altri termini illy era chiaramente il leder italiano (e non solo) del caffè nella definizione dello scenario, di contorni, del settore. Era il riferimento per tutti, consumatori, intermediari commerciali e concorrenti. Scrivo era perchè il fatto che i signori di Capannori si siano rivolti a Lavazza mi sembra un (ulteriore) segnale della perdita di questa leadership.
Ed è un peccato perchè, anche riguardo all’espresso in casa, le idee le aveva tutte in anticipo, con l’ideazione del sistema E.S.E. che prevedeva l’utilizzo di cialde (compostabili) e, soprattutto, l’utilizzo gratuito del brevetto disponibile per tutti. Si evitavano così le inefficenze intrinseche al monopolio di fatto con cui lavorano attualmente le principali case di caffè (illy compresa).
Perchè è successo? Questo ovviamente non lo so. Qualcuno potrebbe dire che è il naturale ciclo di vita delle marche, ma è una visione che io contesto perchè le marche non sono organismi soggetti ai cicli biologici (le persone che le gestiscono però sì), ma sono entità che si alimentano con le idee. D’altra parte anche Lavazza è una marca con di età ragguardevole.
Quello che mi viene da ipotizzare è che illy abbia provato a fare Lavazza, dimenticandosi che se ci si era avvicinata in termini di dimensione era proprio grazie al fatto che proponeva al pubblico uno stile diverso. Stile che ad un certo punto non ha più avuto il coraggio di seguire fino in fondo.
Lavazza invece ha imparato a fare illy (penso al collegamento con l’arte, il design o l’alta cucina), portandosi quantomeno allo stesso livello, sia in termini di qualità intrinseca (capsule+macchine per espresso) che di interlocutore pubblico sulle questioni legate al caffè.
Rivedendo nel mio post dell’anno scorso le dichiarazioni di Andrea Illy sulla riciclabilità delle capsule, spero per l’azienda che fossero frutto dell’amor proprio e non di disonestà intellettuale.
Gestione del personale ed etologia 4
Asterix: Non dovrebbe essere troppo lontano, e a piedi si è veloci come i buoi.. Obelix: Per forza! Anche i buoi sono a piedi.(Asterix e il Falcetto d’oro).
Parafrasando Goscinny, uno dei migliori osservatori della società europea del dopoguerra, mi viene da dire che “il cavallo va a cavallo da quando è nato”.
Da questa apparente ovvietà discende quella che è l’essenza dell’equitazione moderna, secondo cui il cavaliere deve adattarsi in modo da trovare l’equilibrio ottimale del binomio cavallo-cavaliere, così da intralciare il meno possibile il cavallo mentre esegue le indicazioni del che il cavaliere gli ha trasmesso.
Si tratta di una frase densa di concetti che è bene sviscerare:
1. E’ il cavaliere che deve adattare il proprio equilibrio a quello del cavallo. Qui si parla di equilibrio nel senso fisico del termine, perchè ogni cavallo ha un suo baricentro, che cambia alle diverse andature (passo, trotto, galoppo) ed è quindi il cavaliere che deve regolare il proprio assetto in modo che il nuovo baricentro complessivo (cavallo+cavaliere) sia ugualmente efficace come quello naturale del cavallo da solo.
2. Il nuovo equilibrio sarà comunque diverso da quello naturale del cavallo. Questo per sottolineare la necessità che il cavaliere prenda coscienza del fatto che deve essere lui a portare il binomio a trovare questo nuovo equilibrio. Il cavallo stava bene anche da solo.
3. il “valore aggiunto” del cavaliere è la sua volontà. Come sa benissimo qualsiasi cavaliere principiante (come me), il cavallo da solo trotta, galoppa, si ferma, si gira e salta molto meglio da solo che con qualcuno sopra. Il contributo del cavaliere quindi sta essenzialmente nel definire quando e con quanta intensità fare queste cose (nel caso ci fossero degli esperti di equitazione tra i lettori specifico che probabilmente le considerazioni di questo post non valgono nel caso di dressage, alta scuola e similia).
Ed eccoci arrivati al punto centrale: come fare a trasmettere al cavallo la propria volontà? Escludendo la forza, non solo perchè poco etica e quindi poco estetica, ma soprattutto perchè poco efficace, trattando con animali che pesano 400-600 kg, è necessario utilizzare la tecnica.
Senza voler fare un trattato di equitazione (anche perchè non ne sarei asoslutamente in grado), il cavaliere dispone di una serie di aiuti per trasmettere al cavallo addestrato le proprie intenzioni attraverso la voce, le mani (che tengono le redini), le gambe (che fasciano il costato del cavallo), il frustino, la voce e l’assetto (ossia la dislocazione del proprio peso in modo da interagire con l’equilibrio del cavallo). Perchè siano efficaci questi aiuti vanno utilizzati insieme in modo coordinato e coerente e vanno interrotti appena il cavallo capisce cosa vogliamo da lui ed inizia a farlo.
Gli errori nell’uso degli aiuti si dividono quindi sostanzialmente in due categorie:
a) Utilizzo confuso e/o contradditorio degli aiuti: se con la pressione delle gambe indico al cavallo l’intenzione di andare a destra, ma con la posizione delle mani gli indico di andare e sinistra è molto probabile che il cavallo non sappia cosa. Il problema è meno ovvio di quello che sembra perchè l’uso degli aiuti non è meccanico e quindi non è sufficente sapere in teoria quali sono i giusti movimenti e qual’è la giusta sequenza. Bisogna utilizzarli con il giusto equilibrio, che è una cosa quasi più inconscia che razionale. Ecco perchè, ad esempio, verrà molto più naturale fare i movimenti giusti (spostamento dell’assetto, ossia dell’equilibrio, compreso), se quando vogliamo girare guarderemo nella direzione in cui vogliamo andare (per inciso anche in moto le curve vengono meglio se si guarda l’uscita della curva anzichè davanti alla propria ruota).
b) eccessiva intensità e durata nell’utilizzo degli aiuti. Nuovamente, il cavallo non è una macchina, prima di eseguire un comando deve capirlo. E’ quindi necessario che il cavaliere utilizzi gli aiuti con il necessario anticipo e che dia il giusto tempo al cavallo per agire di conseguenza. Se voglio che il cavallo si fermi, stringo i pugni, porto indietro le spalle e spingo in basso i talloni per scendere nell’inforcatura. Se non mi sono dimenticato niente ed ho fatto tutto bene, il cavallo farà ancora alcuni passi e poi si fermerà. A questo punto riprendo l’assetto normale per far capire al cavallo che ha fatto quallo che gli avevo richiesto.
Nel caso in cui l’intesità degli aiuti sia eccessiva o questi vengano utilizzati dal cavaliere anche dopo che il cavallo ha eseguito la richiesta, non è che il cavallo ubbidisca di più, anzi diventerà sempre più “sordo” agli aiuti, che dovranno essere sempre più intensi, fino a quando anche “appendersi” alla bocca del cavallo non servirà più a niente. E’ un circolo vizioso concettualmente simile al problema di “bruciare il comando” visto nei post precedenti relativamente all’addestramento dei cani.
I due tipi di errori tendono a sommarsi, nel senso che io sbaglio nell’uso degli aiuti, il cavallo non fa quello che mi aspetto e quindi io aumento l’intensità delle mie azioni (sbagliate). Il risultato è che il cavallo disimpara quello che sapeva fare. Già questo sarebbe sufficiente a mettere in guardia sulla necessità di non eccedere nella gestione dei propri collaboratori, ma c’è un rischio ancora maggiore che si evidenzia andando a cavallo ed è quando MALGRADO gli errori del cavaliere. il cavallo fa la cosa giusta.
Come già detto più volte, il cavallo non è una macchina, ma un essere vivente, pensante con una sua intelligenza ed emotività individuale (nel senso che ogni cavallo e diverso dagli altri), che sa già fare naturalmente quello che noi gli chiediamo di fare, e per di più è stato addestrato per farlo. Quindi succede più spesso di quanto non si immagini che il cavallo esegue comunque la richiesta del cavaliere, anche se questa è stata comunicata male o con eccessiva forza.
In questo caso quello che disimpara non sarà il cavallo, ma il cavaliere che, convinto che il risultato positivo sia conseguenza delle sue azioni e non dell’intelligenza e della buona volontà del cavallo, persevererà nella cattiva/eccessiva gestione.
Mi rendo conto che questo post risulta un po’ più farragginoso del solito e la cosa non mi stupisce perchè, a furia di rimandarlo, era in bozza da più di un mese. Ad un certo punto il tempo diventa eccessivo ed i concetti si avviluppano su se stessi. Risparmierò quindi i paralleli tra la gestione del cavallo e quella del personale, anche perchè mi sembrano evidenti.
Se c’è qualcosa di veramente incomprensibile, spero che venga fuori nei commenti così da poterlo chiarire.
Con questo post concludo il parallelo tra gestione del personale ed etologia. Spero che nessuno si sia sentito offeso, soprattutto tra i miei passati e presenti collaboratori. Se è così posso scusarmi e sottolineare una volta di più che non era questa l’intenzione.
Concludo dedicando questo post a tre cavalli in particolare:
- Darius: che facendo finta di zoppicare quando lo montavo io, mi ha fatto capire l’importanza dell’individualità.
- Pedro: così generoso da perdonare spesso i miei errori, ma unico cavallo, ad oggi, a farmi volare per terra, facendomi capire con chiarezza animale che non bisogna abusare della disponibilità altrui.
- Dominique: che esige di essere montata bene, altrimenti non si muove, sgroppa, scalcia e così mi costringe ad impegnarmi sempre al massimo.