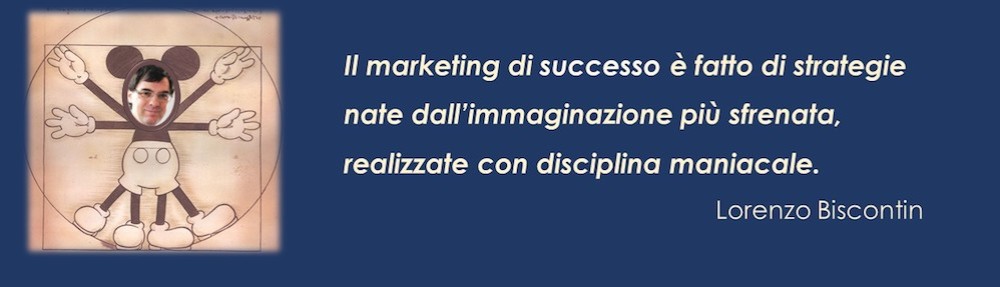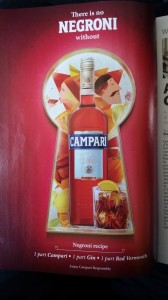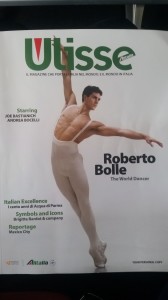“… la nostra prima priorità dovrebbero essere le persone che lavorano per l’azienda, poi i clienti, poi gli azionisti. Perchè se i dipendenti sono motivati, i clienti saranno contenti e quindi gli azionisti guadagneranno attraverso il successo dell’azienda.”
- Richard Branson, Chairman, Virgin
Tempo fa quando sono uscito dopo aver visitato un’azienda mi è venuta in mente questa frase di Richard Branson.
E’ un’azienda che fa risultati, organizzata bene, ma mentre ero lì avevo la sensazione che c’era qualcosa che non mi convinceva del tutto. Andando via ho capito che era la mancanza di energia. Non si percepiva dalle persone nessuna tensione, nessuna spinta nel fare al meglio il proprio lavoro.
Non che ci fossero degli scansafatiche che cercavano di evitare di fare il loro lavoro. E’ che per la maggior parte dei dipendenti il lavoro non era il “loro”, era qeullo che l’azienda gli chiedeva di fare. Erano degli esecutori che aspettavano che qualcuno gli dicesse cosa dovevano fare, per farlo al meglio delle proprie competenze.
Più passano gli anni e più mi convinco che il siccesso duraturo delle organizzazioni passa (anche) dal generare artefici invece che esecutori.
Dico generare perchè il modo e lo stile di gestione hanno un’influenza determinante nel creare le condizioni per cui le persone si comportino come artefici oppure come esecutori.
Cosa intendo per artefice? Una persona che ha la consapevolezza delle sua posizione nell’organizzazione e quindi delle responsabilità che implica. Dalla responsabilità consegue l’autonomia nello svolgere il proprio lavoro e l’autonomia richiede un adeguato livello di informazione, strumenti e formazione.
Io personalmente tendo ad allargare l’informazione oltre al livello necessario per l’autonomia legata alla respondabilità perchè di base sono convinto che se le persone capiscono meglio il contesto in cui operano lavorano meglio, sia a livello di attività che di performances.
La gerarchia delle organizzazioni (dovrebbe) essere strutturata per responsabilità. Io ho sempre posto molta attenzione che non mi venissero assegnate (troppe) resposnsabilità che esulavano dalla mia posizione e dalle mie mansioni e che non me ne venisse tolta nessuna di quelle previste dalla mia posizione e dalle mie mansioni. Di conseguenza esigevo autonomia ed informazioni coerentemente alle responsabilità.
Se le responsabilità (e mansioni) che oltreppasavano il mio ruolo diventavano troppe e/o si prolungavano per troppo tempo, era giunto il momento di parlare di inquadramento e di stipendio.
Tutta questa lunga spiegazione in inglese si sintetizza con il termine di “empowerment“, ossia di dare al personale il potere per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Tra l’altro il termine inglese implica che il potere viene dato (o ceduto) da chi si trova a livelli più alti di responsabilità nell’organizzazione.
In questo modo le persone diventano artefici del proprio lavoro. Gli obiettivi aziendali diventano i loro obiettivi, o meglio vedono come gli obiettivi del loro lavoro giocano sugli obiettivi aziendali.
Attenzione che se l’empowerment, che è molto di moda, viene solo dichiarato e poi rimane nelle buone intenzioni dell’azienda, si trasforma in un boomerang perchè le persone si sentono prese in giro / truffate.
Cosa significa fare l’empowerent sul serio?
Significa creare un ambiente di lavoro basato sul rispetto e la trasparenza nei rapporti personali.
Significa garantire la libertà di parola (d’altra parte è un principio costituzionale) senza che questa venga usata contro chi ha parlato.
Significa dare alle persone la tranquillità di imparare dai propri errori.
Significa seguirle per evitare che le conseguenze degli errori siano troppo gravi (buttare le persone in acqua per vedere se e come sanno nuotare NON è empowerment).
Significa fare prendere coscienza alle persone che sono i primi responsabili della propria mansione, del modo in cui viene svolta e dei risultati ottenuti.
Ci sono alcune frase che dico sempre quando inizio a (dover) gestire un gruppo di persone:
“La gerarchia è nell’organizzazione, non nell’attitudine“. Intendo che un’organizzazione funziona bene se c’è una gerarchia (piatta) basata sulle responsabilità e la capacità di utilizzare tutte le conoscenze e competenze delle persone che la compongono. Come si sul dire, non esistono domande stupide (se sono fatte in buona fede).
“Non sono io che devo dirvi cosa fare, sei voi che dovete chiedermi quello che vi serve per fare bene il vostro lavoro”
“Il fatto che io sia responsabile anche del vostro lavoro, non vi solleva dall responsabilità di quello che fate e come lo fate” (vedi punti precedenti). Esempio: il fatto che ci sia un correttore di bozze non esime chi scrive da fare attenzione agli errori di ortografia e grammatica perchè un testo zeppo di errori costringerà il collega ad un maggior lavoro (mancanza di rispetto, vedi sopra) ed aumenta il rischio che qualche errore sfugga (peggioramento della perfomance).
Era il 1983 quando facendo il corso caporali ho scoperto che la consegna è “precisa, coincisa, tassativa”.
Oramai perfino negli eserciti hanno attenuato questi principi per migliorare efficacia ed efficienza.
Dispace vedere aziende che di fondo operano ancora con principi ottocenteschi, per di più con con consegne confuse, prolisse ed aleatorie.