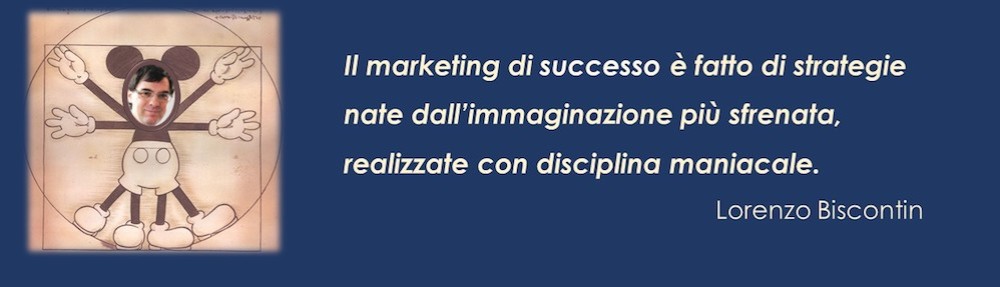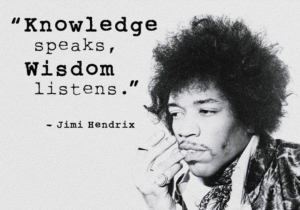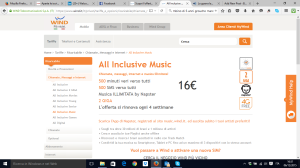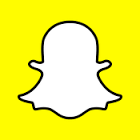Come in qualsiasi altra cosa anche nella gestione aziendale e nel marketing ci sono le mode e oggi vige quella del “content marketing”.
Basta pubblicità ma contenuti comunicati direttamente dalle marche ai propri pubblici di riferimento (chiamateli audiences, targets o come più vi piace) attraverso i propri profili sui social networks.
Il problema è che è il messaggio che fa il messaggio non (più) il mezzo.
Quindi i profili social della stragrande maggioranza delle marche sono pieni di contenuti “pubblicitari” (quando non sono “morti”, lasciati mesi interi senza aggiornamenti).
La foto dei titolari davanti alla nuova sede o quella del nuovo prodotto sono contenuti “pubblicitari”
Il post del venerdì con scritto “Finalmente è arrivato il week-end, ci beviamo un bicchiere del nostro XYZ. E voi con cosa brindate?” è un contenuto pubblicitario. E nemmeno tanto originale. Neanche a Pasqua, Natale, Hallowen, ecc..
Il risultato è che l’engagement dell’attività di content marketing si riduce ad amici e parenti.
E’ un problema? Dipende dalla dimensione della marca e dai costi (di risorse e di tempo) che dedicate alla comunicazione sui social, ma in linea di massima sì perché amici e parenti la marca la conoscono e la preferiscono comunque.
Da quando esistono gli sms gli esperti di marketing e comunicazione si interrogano periodicamente su cosa bisogna fare perché un contenuto abbia maggiori probabilità per diventare virale. Qui trovate un mio post del 2013 che spiega l’approccio STEPPS.
Oggi la faccio ancora più facile per i colleghi che si occupano a vario titolo di marketing e comunicazione. Basta che pensiate a cosa hanno in comune le marche che seguite sui social, esclusi concorrenti, amici, parenti e conoscenti, o cos’hanno i contenuti che condividete.
Nella grandissima maggioranza dei casi si tratta del fatto che non parlano della marca, prodotto ecc…, ma parlano di cose che riguardano le persone. Detto ancora più in sintesi, le persone non condividono i contenuti che parlano di voi, ma quelli che parlano di loro.
Gli affezionati lettori di biscomarketing e chi partecipa alle lezioni che tengo ai vari corsi in cui hanno la bontà di chiamarmi sa che non solo concordo sul fatto che oggi siamo tutti nel business dell’editoria, intesi come creazione di contenuti, ma anche che sostengo che lo siamo sempre stati.
Con questo intendo dire che anche ai tempi della comunicazione monodirezionale (che poi era un’illusione perché le persone tra di loro parlavano anche prima ed il passaparola poteva determinare il successo o il fallimento di una marca, solo che le aziende non potevano sentirlo come lo sentono oggi) la pubblicità più efficace nel posizionare una marca nel periodo medio lungo era quella che comunicava contenuti.
Per una volta invece di tediarvi con lunghe disquisizioni, mi spiego con alcuni esempi.
Il primo è la campagna pubblicitaria che Aldi ha fatto sui social per l’apertura dei suoi punti vendita in Italia. E’ stata una campagna pubblicitaria di successo perché il messaggio parla una cosa che interessa alle persone: una nuova opportunità per risparmiare sulla spesa.
La campagna si è articolata in due fasi: prima con degli spot con protagonisti italiani che vivono all’estero e poi con protagonisti famiglie italiane di cognome Aldi che provavano i prodotti della catena. Una modalità interessante, quindi metto i due esempi:
Il secondo esempio è un video, non so se si può definire una campagna pubblicitaria ma spero che a questo punto abbiate capito che la differenza ha (secondo me) poca importanza, realizzato dalla compagnia aerea scandinava SAS.
Il terzo esempio è il video dell’esperimento fatto dalla catena di supermercati tedesca Edeka che ha tolto dagli scaffali di uno dei suoi supermercati tutti prodotti non tedeschi per mostrare gli effetti tangibili della visione nazionalista di chiusura verso gli altri (paesi).
Prima che vi lamentiate perché sono troppo teorico ed astratto, concludo linkando il post di Pier Luca Santoro su Data Media Hub sui “12+1 errori da NON fare sui social” (no, non ho cointeressenze; solo stima).